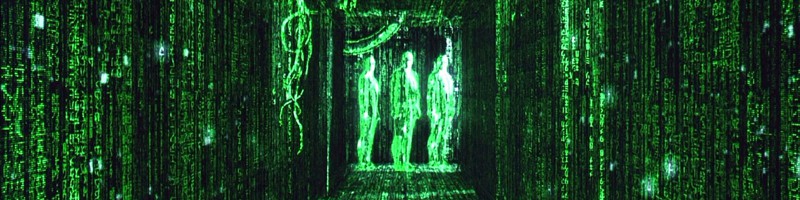
A fronte dell’incontrollabile flusso di notizie presenti nel mondo del web
l’unico rimedio attuabile è l’esercizio salutare del dubbio.
Notizie false o prodotti della post-verità?[1] Una polemica furibonda è in atto su tutti i canali di comunicazione, dai giornali alla tv, alla rete.
Due le scuole di pensiero che si fronteggiano: quelli che fanno rientrare il fenomeno in una tradizione consolidata (le “balle” pubblicistiche ci sono sempre state) e quelli che ravvisano qualcosa di nuovo, di originale e di ingovernabile nelle manifestazioni più sofisticate del fenomeno.
La prima posizione non richiede approfondimenti perché si basa sull’evidenza dei fatti: si pensi ai titoli sul mostruoso “serpente di mare” dei giornali dell’Ottocento o al panico suscitato dalla mitica radiocronaca di Orson Welles sull’invasione della Terra da parte dei marziani.
La seconda posizione esige invece un’indagine che metta a fuoco la differenza specifica del presente.
Una certa idea di autorità
Non è un tema agevole in un contesto di complessità che non sopporta semplificazioni mentre ogni tentativo di lettura viene dominato dalla smania di riportare tutto ad un sistema duale, all’“aut-aut” invece che all’“et-et”. Con esiti finali che, solo in apparenza, fanno onore alla logica. Sicché, di fronte a qualche sviluppo che desta preoccupazione, quelli della prima scuola segnano il passo sull’idea che non c’è niente da fare, mentre quelli della seconda inventano soluzioni che, in qualche caso, feriscono il principio di libertà che, in democrazia, regola il mondo dell’informazione.
Appartengono a questa famiglia le ipotesi di mettere all’opera autorità di controllo che intervengano, a seconda dei gusti, o a monte o a valle delle distorsioni.
Nel primo caso si inventa una sorta di “ministero della verità”, cioè di un’autorità che vagli preventivamente le notizie prima di metterle in rete, che centralizzi (con un criterio evidentemente politico) le funzioni di selezione le quali, nella pratica giornalistica, sono svolte dai desk delle agenzie di stampa, quelli che una volta si chiamavano “gli addetti al traffico”.
Tra “minculpop” e giurie popolari
Nel secondo caso – quello dell’intervento a valle – si agisce su una vasta tastiera di ipotesi, la più intrigante delle quali è senza dubbio rappresentata, in Italia, dalla suggestione di Beppe Grillo, di creare per sorteggio delle “giurie popolari” con il compito di individuare, denunciare e indicare al pubblico ludibrio i giornali e i giornalisti, della stampa e della TV (ma non del web) che sarebbero i principali responsabili della disinformazione dilagante.
Su entrambi i fronti ci si imbatte però in osservazioni difficilmente aggirabili. È evidente che, anche senza creare un apposito ministero (che sarebbe parente del Minculpop fascista o dei suoi omologhi di diverso colore), l’interruzione dei flussi informativi configurerebbe una censura preventiva. Il che – per non dire altro – confliggerebbe con l’art. 21 della Costituzione per il quale «la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure».
Ed è altrettanto evidente che, per le stesse ragioni, non troverebbero cittadinanza democratica misure estemporanee di repressione, tanto più se decisamente mirate contro una funzione, come quella dell’informazione, le cui deviazioni sono del resto già perseguite dalla legge quando assumono la configurazione di reati.
Un sistema irresponsabile
Sono questi i paletti che delimitano il perimetro di ogni eventuale iniziativa che si voglia assumere per eliminare o attenuare gli abusi dell’informazione, intesi come effetti indesiderati dell’esercizio di un diritto che va comunque garantito. E sono altrettante le cautele da osservare da parte di chi ultimamente è sembrato intenzionato a metter mano ad imprese di questo genere, si tratti del responsabile dell’autorità per la tutela della concorrenza o dello stesso ministro della giustizia.
Quest’ultimo, peraltro, ha messo a fuoco quello che a me sembra essere il vero centro del problema e cioè l’effettiva singolarità del fatto che nella rete – cioè il contenitore nel quale ciascuno di noi può riversare i “contenuti” che desidera, da una composizione poetica a una collezione di insulti o diffamazioni – nessuno si considera responsabile di ciò che nella rete medesima è immesso o sulla rete transita. Con due differenze sostanziali rispetto ai media tradizionali: l’ampiezza della diffusione, che coincide con l’orbe terraqueo, e il “tempo reale” cioè l’immediatezza della ricezione.
“Virale” come virus
Su queste coordinate che si dispiega quello che è stato chiamato il carattere “virale” di quei messaggi, o immagini, che vengono rilanciati all’infinito e producono un effetto di valanga informativa a prescindere dalla fondatezza o dall’attendibilità di quel che contengono.
È qui che si compie il paradosso di goebbelsiana memoria per cui una menzogna ripetuta più volte si accredita come verità. Con la differenza, rispetto al passato, che non ci sono più gli intervalli tecnici tra – diciamo così – il concepimento della notizia e la sua ricezione: il tempo di stampa e di diffusione, la corsa della staffetta, il volo del piccione viaggiatore, la pausa di trasmissione per telefono, per fax o per telescrivente.
Virale viene da “virus” ed evoca qualcosa che somiglia alla diffusione di un’epidemia; e così viene spontaneo mettersi alla ricerca dell’untore, magari individuandolo tra coloro che hanno mostrato di frequentare più di altri il mondo del web, vale a dire i populisti, come ha argomentato Ezio Mauro.
Autocontrollo e business
I gestori dei principali network su cui transitano i flussi dei “contenuti” si sono resi conto della serietà del problema e hanno escogitato forme di intervento sui “post”, con criteri assolutamente privati che si prestano a più di un rilievo.
Secondo quanto ha scritto la Repubblica del 27 dicembre 2016, Facebook, il più grande “social” del mondo, si sarebbe dotato di un codice etico in base al quale vengono filtrati i messaggi. Con esiti invero opinabili se, ad esempio, venisse cancellata l’espressione “i migranti sono sporcizia” mentre sarebbe accettata l’altra: “i migranti sono sporchi”. Analogamente, ci sarebbe via libera per le critiche rivolte ad una religione ma non per i seguaci della stessa.
Quanto efficace sia l’applicazione di tali criteri è materia di difficile apprezzamento. Ma non è azzardato ritenere che si proceda con una certa cautela, visto che gli interessi economici del network vanno nella direzione della massima intensità ed estensione dei flussi.
Più si pubblicano notizie, foto, informazioni o anche i semplici “like”, tanto più si può chiedere in moneta per la pubblicità sul sito interessato e per la piattaforma di condivisione.
Al prossimo G7?
Qui si impone una considerazione impegnativa, che parte dalla constatazione della non neutralità delle piattaforme, perché il business non è mai neutrale, si sviluppa sull’esigenza di valutare anche i risvolti economici del problema e si conclude sulla necessità di identificare per le piattaforme un livello di responsabilità, a somiglianza di quanto avviene per i giornali, dove all’autore di un articolo che reca danno a qualcuno si affianca sempre, anche in tribunale, la persona del direttore responsabile.
Con le peculiarità del caso, ovviamente, giacché nella rete non è immaginabile una figura che dia il “visto si stampi”, ma si deve piuttosto immaginare un ingegnere chiamato a regolare il deflusso delle acque di una diga.
Il ministro Orlando asserisce che di tutto questo si parlerà al prossimo G7; e va preso in parola. Ma sarebbe illusorio pensare che una qualche soluzione possa essere escogitata a breve termine o che la semplice indicazione di specifiche figure responsabili basti a chiudere il capitolo.
Nel popolo dei network
C’è un altro versante che resta tuttora inesplorato ed è quello che riguarda il popolo dei network, quello che passa buona parte del tempo della vita con gli occhi fissi sul telefonino dal quale attinge – ormai quasi come unica fonte – le informazioni sulle quali si basa per le scelte personali e politiche, da quel che puoi comprare ai saldi del mercato a quel che potrai votare alle elezioni.
L’irruzione dell’informazione elaborata e trasmessa in tempo reale ha sconvolto l’equilibrio razionale degli anziani, ma è intesa come una condizione fisiologica dalle nuove generazioni. È inimmaginabile che si possa loro proporre di tornare indietro; e poi, quanto indietro?
Qui il tema si manifesta come l’istanza di una conquista: servirsi della rete senza cadere nella rete. Conquista cioè di un senso critico che non distolga gli occhi dal tablet ma spinga a rendersi conto che quel che si legge o si vede sul minuscolo schermo miracolosamente collegato col mondo non è necessariamente né la verità né la realtà delle cose e degli eventi, ma solo – precisamente – una post-verità, cioè una verità manipolata che chiede non la passività dell’adesione ma l’esercizio salutare del dubbio.
Nota autobiografica
Era semplice, ai tempi miei, spiegare ai ragazzi come si doveva leggere un giornale tenendo conto di chi c’era dietro la testata: un partito, un gruppo sociale, un potentato economico; e ognuno metteva il suo sigillo sulle opinioni; e il confronto ordinato delle opinioni portava vicino alla sintesi. Le grandi associazioni erano i veicoli per ottenere tali risultati.
Oggi procedure del genere non sarebbero riproducibili. Ma forse una parte del metodo potrebbe essere recuperata attraverso la mediazione di gruppi di attenzione o di discernimento, o come altro li si voglia chiamare, che si riuniscano e riflettano sui messaggi che hanno intercettato e sulle reazioni che hanno prodotto in loro. E forse, perché no? per interloquire nella grande arena del web introducendovi, se c’è, un pensiero non automatico ma autentico perché filtrato dall’esperienza. Per farlo non c’è bisogno di una legge. Il luogo, volendo, si trova; e anche chi è in grado di formulare un indice di ricerca. E tenere spento il telefonino per un’ora può essere un esercizio di virtù.
[1] Il neologismo post-verità deriva dall’inglese post-truth. L’Oxford English Dictionary ha deciso di eleggere post-truth come parola dell’anno del 2016 (Wikipedia).






Nessun commento