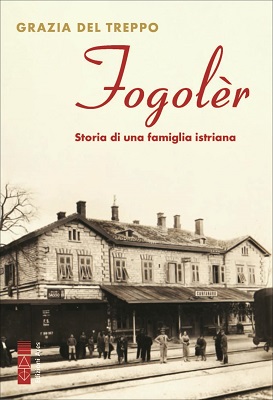
Grazia Del Treppo (Pola 1941) è l’autrice del volume “Fogolèr. Storia di una famiglia istriana” (edizioni Ares 2025). Nella “Giornata del ricordo” le chiediamo di consegnarci una memoria dei drammatici fatti che hanno coinvolto anche lei – bambina – con la sua famiglia.
– Gentilissima Grazia, come mai questo suo libro solo ora?
Come mai scrivere un libro al crepuscolo della vita? I motivi sono almeno due: uno di tipo affettivo e l’altro di carattere storico. Ciò che racconto nel libro vive nella mia anima da sempre: ho desiderato scrivere per onorare la memoria dei miei vecchi, nonni e genitori, per chi non ha più voce e per lasciare un patrimonio di memoria ai miei figli.
L’altra motivazione – che potrei definire politica – è che per più di settant’anni la storia degli Italiani del confine orientale è stata ignorata dai connazionali: questo silenzio è stato purtroppo voluto e i libri di storia non ne hanno parlato. Mentre noi istriani siamo stati assorbiti dal grande sforzo di ricostruire il nostro fogolèr in Italia con grande dignità e nel silenzio colpevole che ci circondava. Eravamo italiani invisibili.
Giunta a questa età, mi sono detta: io e i miei coetanei siamo gli ultimi testimoni diretti di quelle vicende, e abbiamo perciò il dovere di raccontare quello che è successo in Istria in quegli anni perché sulla nostra storia non cali il silenzio per sempre.
È emblematico il fatto che molti italiani passano le vacanze in Istria e Slovenia e al ritorno dicano «che belle Pula, Poreč, Koper, anziché Pola, Parenzo, Capodistria…», ignorando totalmente il passato italiano di quelle città. Eppure, tutto ancora ne parla: i resti romani, le bifore veneziane, lo stile delle costruzioni. La costa occidentale dell’Istria è tutta, culturalmente, italiana, mentre l’interno istriano è il prodotto di una composizione, in parte slava e in parte italiana: e questa è stata la vera ricchezza di quella terra.
– Come ricorda il rapporto tra italiani e slavi nel suo paese natale?
Il mio paese natale, Canfanaro, si trova all’interno, a dieci chilometri dalla costa. Ricordo – dalla mia prima infanzia – un sereno clima di convivenza con la minoranza slava. Mio padre era un imprenditore e aveva molti contadini e operai slavi alle sue dipendenze, che erano amici e ogni giorno venivano a tavola da noi. Il linguaggio quotidiano comune era un misto di dialetto veneto, unito ad espressioni croate e a parole austriache, perché i confini permeabili dell’Istria erano stati attraversati dai diversi domini.
La serenità della vita in comune fu rotta tragicamente dall’arrivo del comunismo. Tito inviò in Istria due suoi fidi collaboratori –Milovan Dilas e Edvard Kardelj – esponenti del partito comunista jugoslavo, con un ordine ben preciso: «Dovete fare di tutto per cacciare gli Italiani»; e, di fatto, l’operazione fu realizzata nel terrore, con le prigioni e le foibe.
Tito ha voluto cancellare una cultura millenaria, svuotando l’Istria, Fiume e la Dalmazia dell’elemento italiano: partirono da quelle terre 350mila italiani.
***
– Vuol iniziare a raccontare la sua vicenda?
Il 25 aprile del ’45 per noi non è stata la liberazione ma l’inizio di una tragedia, perché arrivò, appunto, Tito. Non ci portò certamente la promessa libertà e la fratellanza. Molti avevano già intuito come si sarebbero messe presto le cose: in particolare i liberi professionisti, gli imprenditori, i medici, che partirono per primi.
I miei genitori optarono per la cittadinanza italiana, il che significava poter uscire – su istanza – dalla Jugoslavia per venire in Italia. Ma, purtroppo, la nostra richiesta fu respinta da Zagabria per ben quattro volte. Nel frattempo, accaddero fatti molto gravi: la prigionia di mia mamma, i lavori forzati di mio padre, il martirio di don Miroslav Bulešić
– Ci può parlare delle foibe?
Rappresentano la tragedia più grande. Le foibe sono fosse profonde e strette, tipiche del terreno carsico. Un primo allarme sulle foibe si ebbe dopo l’armistizio del ’43. Già allora si venne a sapere di persone sparite di notte, caricate sui camion, detti “camion della morte”.
Gli uomini di Tito rapivano uomini, donne e ragazzi: dicevano, per interrogarli, invece, li portavano nei boschi dove ci sono le foibe (circa trecento), spogliavano le persone nude per evitare il riconoscimento delle salme, le legavano col filo spinato ai polsi a gruppi di cinque e le mettevano di fronte alle fosse – che sono profonde da cinquanta a trecento metri –, sparavano alla prima persona del gruppo, la quale, cadendo, trascinava le altre quattro, che agonizzavano per giorni.
Le urla strazianti si sentivano da lontano, tanto che i “titini” gettavano nelle foibe anche capretti e altri animali per coprire le voci disperate.
Nelle foibe sono finiti sedicimila italiani. Le foibe sono luoghi sacri, cimiteri senza una croce, senza un fiore, senza un segno sacro. Tra le persone infoibate suscita particolare dolore il dramma della giovane Norma Cossetto, ventenne, stuprata da 17 “partigiani” dal 1° ottobre 1943 all’alba del 5 ottobre, e poi infoibata.
– Perché mamma e papà furono arrestati?
Mia mamma andava in chiesa tutte le volte che poteva, quando c’era la presenza del sacerdote: molti sacerdoti, infatti, furono impediti dal comunismo di svolgere il loro ministero; cinquanta furono assassinati.
Una domenica di primavera, mentre eravamo dai nonni a giocare, arrivarono due personaggi in borghese, emissari della polizia politica, la famigerata OZNA (acronimo che in italiano significava dipartimento per la protezione del popolo), e puntarono gli occhi su mia madre dicendo: «Compagna, seguici!».
Ricordo ancora la scena della mamma – vista coi miei occhi di bambina – scortata da quei due, e mio padre che cercava di raggiungerla, fermato bruscamente dai poliziotti. Ma l’immagine che porto più fortemente impressa dentro di me, è di quella sera in cui mio padre – che non sapeva ancora dove fosse stata portata la mamma – si sedette, pose me e il mio fratellino sulle sue ginocchia, e scoppiò a piangere. Mio papà era un uomo giovane, bello, forte, robusto, che io pensavo non fosse capace di piangere. In quel momento ho creduto che mia madre fosse morta.
Dopo otto giorni di silenzio, venimmo a sapere che la mamma era prigioniera a Pola, accusata di “propaganda religiosa”. In cosa consistesse tale accusa non lo venimmo mai a sapere. Le costò due mesi di prigione – senza processo – in cella con altre venti donne. Ritornò a casa per la festa del Corpus Domini, proprio durante la processione.
Mio padre, poi, fu considerato, “nemico del popolo”, perché, secondo il comunismo, tutti i proprietari terrieri, gli imprenditori, i commercianti e i negozianti erano ritenuti sfruttatori del popolo per definizione.
Un giorno stava festeggiando con gli amici l’uccisione del maiale – come in ogni fine inverno – intonando canti italiani, tra cui il Va’ pensiero di Verdi. Il mattino successivo tutti furono convocati dall’OZNA e, in seguito, processati e condannati. Ricordo bene il titolo di un giornale dell’epoca, che li definì “I banditi di Canfanaro”: banditi, appunto, perché “nemici del popolo”; eppure mio padre, quando possedeva la macelleria, ogni sera riservava la carne per le famiglie più povere di Canfanaro.
Papà fu mandato ai lavori forzati – lavori volontari, così li definiva il regime – in un’isola del Quarnaro, per sei mesi. E i poveri del paese non ebbero più carne da mangiare.
***
– Come avvenne la persecuzione dei cattolici?
In quel periodo di permanenza forzata per mancanza del permesso d’espatrio, avvenne un episodio terribile. Dal 1945 avevamo un nuovo parroco, un giovane parroco croato, don Miroslav Bulešić, bilingue. Lui aveva fatto rifiorire la parrocchia, con l’eucaristia, col catechismo dei bambini e con molte altre attività. Io gli devo molto. Aveva molto coraggio. I comunisti di Tito non gli facevano paura, anzi lui li affrontava apertamente.
Il suo fervore e il suo zelo fecero sì che molti giovani e uomini maturi lasciassero la sezione del partito comunista per andare in chiesa, e ciò non era chiaramente tollerabile da parte dei “titini”. Don Miro – così veniva familiarmente chiamato – avrebbe dovuto tornare a Roma per terminare il suo ciclo di studi teologici presso la Gregoriana, ma, vista la difficile situazione della parrocchia, decise di rimanere, pur essendo cosciente dei pericoli che stava correndo, consapevole della possibilità del martirio.
Le celebrazioni delle Cresime, per un periodo, furono proibite. Ma poi il Governo diede l’autorizzazione. Ad Antignana e a Pinguente, prima della funzione, il sagrato della chiesa fu invaso da orde di comunisti che, urlando e bestemmiando, impedirono l’amministrazione del Sacramento.
Il fatto allertò le celebrazioni delle settimane successive, in particolare in una località del nord, Lanischie, ove erano programmate per il 24 agosto (1947), presiedute dal vescovo, mons. Ukmar, col parroco locale e con l’aiuto di don Miro. Memori del fattaccio della settimana precedente, i celebranti anticiparono la funzione di un’ora, alle otto anziché alle nove del mattino.
I padri dei cresimandi erano rimasti sul sagrato per evitare l’ingresso in chiesa degli eventuali facinorosi che erano soliti a profanare l’eucaristia. Finita la santa Messa, i sacerdoti si ritirarono in canonica. In quel momento sopraggiunsero i “titini” che, intuendo di essere stati raggirati, divennero ancor più feroci. I genitori scapparono con i figli mentre gli aggressori sfondavano la porta della canonica, imprecando e compiendo violenza: picchiarono mons. Ukmar riducendolo in fin di vita; cercarono don Miro, lo trovarono nell’ufficio parrocchiale e lo uccisero con una pugnalata alla gola.
Questo fatto di sangue ebbe risonanze in tutta l’Istria, perché don Miro era amato e conosciuto da tutti. Alla cerimonia funebre fu proibita la partecipazione della popolazione; furono ammessi solo la madre, la sorella e il fratello che dovettero portare la bara per la funzione funebre. Questo accadde nel 1947, in tempo di pace. Don Miro Bulešić è stato poi beatificato all’Arena di Pola il 28 settembre 2013, alla presenza di 25mila persone.
– In Italia come è arrivata?
Ci fu dato il permesso di partire nel febbraio del 1951 verso quell’agognata Italia che, dopo tali atroci fatti, sognavamo tanto. Siamo giunti dapprima ad Udine, secondo il percorso seguito da tutti i profughi istriani. Alla partenza, i comunisti offrirono a mio padre un ruolo di spia dall’Italia: ciò ci avrebbe evitato la permanenza nei campi profughi, per cui saremmo entrati subito in possesso di una casa. Ovviamente mio padre rifiutò. A Udine avveniva lo smistamento e noi fummo inviati a Roio Pineta, provincia dell’Aquila: un lungo viaggio in treno, dunque, dal mare istriano alle montagne abruzzesi.
Fummo alloggiati in una ex colonia per bambini costruita durante il fascismo, e sistemati in un enorme camerone in cui ogni famiglia viveva in un box, separati dalle altre famiglie con coperte grigie.
Neppure in una tale situazione ho mai visto nella mia famiglia qualcuno arrabbiato, lamentarsi o piangere. Mia mamma si rallegrò di avere a disposizione nel nostro box metà della finestra dalla parte della maniglia.
Non ho percepito mai odio, né rabbia, né autocommiserazione, tra noi. È ripartita subito, invece, la voglia di creare comunità. Mio papà allestì in quel soggiorno abruzzese una squadra di calcio per i bambini; una signora creò un coro per cantare in chiesa. Pur in un ambiente così povero, la vita stava rinascendo e di questo sono rimasta molto grata ai miei genitori, alla mia comunità.
Da Roio Pineta speravamo di poter raggiungere Torino, dove mia madre aveva parenti. Racconto, in proposito, un breve aneddoto che descrive il clima sereno di quel tempo, nonostante le gravi difficoltà e la povertà estrema: gli amici istriani di mio padre, viste le sue competenze, lo spingevano ad accettare la destinazione di Torino, dicendogli: «Se andrai a Torino, vedrai che farai strada!». Appena giunto nel capoluogo piemontese, il papà si presentò nel posto in cui si offriva il lavoro: venne assunto da un imprenditore che lo portò ad asfaltare la strada che conduce alla Basilica di Superga. Ritornato al campo profughi dal lavoro, anziché imprecare contro la malasorte o di dispiacersi per l’umile e pesante lavoro, abbracciò mia madre e ridendo le disse: «Hai visto Stefania: ho fatto strada!».
L’istriano è un gran lavoratore, capace di lavorare cantando, di lavorare sodo per poi fare festa. Le stesse festività religiose erano profondamente sentite da noi, in chiesa con cerimonie solenni, ma poi sempre si concludevano a tavola, in allegria.
A Torino, nel campo profughi delle Casermette San Paolo, avemmo una stanza tutta per noi. Siamo stati accolti bene e noi ragazzi eravamo seguiti dai sacerdoti e dalle Suore missionarie della Consolata. Tanti ragazzi e tante ragazze come me, ferite dal distacco dalla propria terra e dallo sradicamento culturale, hanno potuto vivere un’esperienza gioiosa, per la vita comunitaria che c’era.
Quando la mia famiglia ottenne infine una casa propria in muratura, io e mio fratello non volevamo più lasciare il campo profughi, tanta era stata la gioia vissuta con i nostri compagni e le nostre compagne di gioco, per la formazione umana e religiosa che avevamo ricevuto.
***
– È possibile parlare oggi di riconciliazione?
Non penso sia avvenuto un serio ripensamento di quei fatti tragici né che si possa parlare ancora di una riconciliazione. Personalmente, mi sento riconciliata con i croati del mio paese, a cui non imputo nulla, perché da loro non ho ricevuto alcun male. È stato il comunismo di Tito a farci molto male. Ma non voglio tacere neppure il male in precedenza perpetrato dal fascismo in Istria sulla popolazione croata, che tuttavia non aveva provocato né infoibamenti né esodi di massa.
La mia serenità – e quella della mia famiglia – nei confronti dei croati è sicuramente favorita dal fatto di non aver avuto congiunti infoibati: chi può infatti provare lo strazio e i sentimenti di quelle persone che sono state private, in quel modo, degli affetti più cari? Come chiedere loro di sentirsi riconciliati?
Oggi, peraltro, la popolazione italiana in Istria è ridotta e, nonostante l’impegno delle Associazioni degli italiani, è una minoranza.
– È tornata in Istria a presentare il suo libro?
Quando l’ho presentato a Pola, il pubblico era composto da italiani, mentre alla presentazione svoltasi a Canfanaro c’erano italiani e croati, amici che hanno voluto farmi festa insieme, perché ho dato loro visibilità nel ricordo di quei tragici fatti di cui, in fondo, tutti siamo state vittime, senza portare rancore.
– L’istituzione della “Giornata del ricordo” ogni 10 febbraio dal 2004 ha contribuito a fare luce su questa pagina oscura della storia del nostro Paese?
Certamente ha contribuito e contribuisce a dare maggiore risalto storico al dramma che noi abbiamo vissuto. Io ringrazio i promotori della legge che ha istituito in Italia questa commemorazione civile nazionale, così come il Parlamento che ebbe ad approvarla. Per me – e per noi anziani esuli istriani – è stata di stimolo per contribuire alla custodia della memoria.
In questa Giornata vorrei evidenziare le figure dei nostri vecchi, quelli che erano vecchi già allora: la loro è stata una tragedia nella tragedia. Noi giovani e bambini, infatti, avevamo comunque un avvenire davanti, mentre loro avevano soltanto un lungo passato che hanno dovuto di colpo lasciare alle spalle.
Accaddero episodi drammatici: anziani pescatori lasciati senza barca, contadini lasciati senza terra a passare le giornate a contemplare in silenzio, dalla Riva di Trieste, l’amata terra istriana: qualcuno affogò il dolore nell’alcol. Mio nonno – un uomo sino a quel tempo attivissimo e creativo – si chiuse per sempre in un profondo silenzio.
***
– All’insegnante in pensione, chiediamo: come “insegnare” in questa Giornata?
Accetto sempre con entusiasmo – ma anche con trepidazione – incontri con gli studenti. Racconto la mia cruda verità, ma mai in un modo che questa possa suscitare odio o rancore o sentimenti di rivalsa. Non ne faccio mai una questione politico-ideologica. Non voglio che i croati siano identificati col comunismo.
Tali sentimenti di odio ideologico – coltivati nell’animo – sono serpi che non tolgono, a chi l’ha provato, il dolore, ma possono solo propagarsi in maniera negativa nel tempo.
Cerco di spiegare ai giovani come – tra mille difficoltà e ristrettezze, vera povertà e miseria – siamo riusciti a ricostruire la nostra vita, rimanendo uniti come famiglia, tra famiglie, e in comunità. Il mio intento è quello di promuovere pace, fiducia, fede.
– Grazia, lei parla di fede anche nelle scuole?
Sì, e, a proposito di fede, ricordo sempre come mia madre, nei due mesi di carcerazione vissuti insieme a donne prostitute, fattucchiere e delinquenti comuni, pregasse continuamente con il rosario tra le mani. Di fronte al secondino ebbe a dire, con grande coraggio: «Guarda che io prego anche per te, perché tu ti converta».





