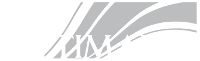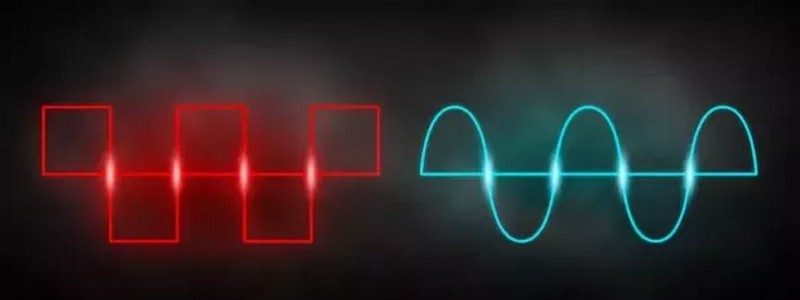«I processi digitali segnano in profondità la società e la comunicazione. Fenomeni come i Big Data, industria 4.0, Internet delle cose, robotica e le domande di un’etica digitale rivestono un ruolo crescente. La velocità dello sviluppo delle applicazioni digitali è affannosa». «Siamo testimoni di un tempo di enorme progresso che dobbiamo osservare con occhi curiosi anche come Chiesa». L’osservazione fa capo ad una commissione della segreteria della Conferenza episcopale tedesca dal titolo “Formazione mediale e diritto alla partecipazione” (Arbeitshilfen 288, settembre 2016).
Pochi mesi fa è uscito un volume curato da Adriano Fabris e Ivan Maffeis, Di terra e di cielo, che si presenta come «manuale di comunicazione per seminaristi e animatori» (San Paolo, Milano 2017).
Don Maffeis è sottosegretario della Conferenza episcopale italiana e direttore dell’ufficio per le comunicazioni sociali. Fabris è professore a Pisa e nome noto fra gli esperti della comunicazione.
Il volume si presenta come un sussidio all’interno di un’attenzione dei vescovi che ha come riferimento rilevante il Direttorio sulle comunicazioni sociali (Lev, Roma 2004). Sul tema è uscito anche un numero di Documents Episcopats del segretariato generale della Conferenza episcopale francese, dal titolo «Chiesa in rete. Quale comunicazione nell’era del numerico?» (n. 5, 2017).
Analogici e digitali
Il rischio che tutti avvertono è quello di interpretare il trattamento di una modalità specifica del comunicare (riduzione a una sequenza binaria 0 – 1) come modalità di comprensione di ogni interazione, premessa di una sorta di egemonia culturale che pretenda di spiegare e regolare il modo con cui l’essere umano si comporta. Ma anche di evitare «narrazioni pigre» e dimissionarie (C. Giaccardi): il dualismo digitale (solo il reale è vero, il virtuale è realtà impoverita), il determinismo tecnologico (la tecnologia uccide l’umanesimo), il divario digitale (è cosa per “nativi digitali” non riguarda gli altri).
Ha buon gioco don Maffeis a ricordare la continuità dell’attenzione ecclesiale alla comunicazione. Dal magistero conciliare (Inter mirifica e poi Communio et progressio) a quello episcopale (il già citato Direttorio), fino agli interventi più recenti, i più vicini alle novità della comunicazione digitale: i massaggi di Benedetto XVI e di Francesco per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
La paura odierna del venir meno di un messaggio autoritativo nella Chiesa deve fare i conti con una storia che è plurale fin dall’inizio: dal vangelo quadriforme ai retabli da viaggio, dalla novità degli ordini mendicanti alla permanenza di opinioni diverse anche nei secoli della Contro-Riforma e di un progressivo sistema di controllo della parola scritta. La disputa giansenista e il ruolo delle Provinciales di B. Pascal ne sono un esempio: «Fu l’apparire di un’istanza nuova, il “pubblico”, a indebolire i gesuiti (oggetto della polemica) che si ostinavano a risponde a Pascal sul versante della teologia morale».
Era la stampa a vincere e a modulare una prima opinione pubblica nella Chiesa (Documents, p. 12).
L’esplosione dei media attorno all’evento conciliare può essere letto come un anticipo dell’esplosione delle virtualità comunicative contemporanee.
Flusso comunicativo e dottrina sociale
Il flusso comunicativo ha oggi la forza economica e culturale delle materie prime (carbone, energia elettrica e poi petrolio) nella rivoluzione industriale. Il dato tecnico (la digitalizzazione dei dati) è già diventato un progetto economico: Big Data, industria 4.0, nuovi modelli sociali, lavoro digitale, sharin economy ecc. Esso è guidato dalla razionalità economica e tecnica e non immediatamente dal bene comune.
La regolamentazione politica e i principi della dottrina sociale ritornano ad essere decisivi. La centralità della persona, la solidarietà e la sussidiarietà, il bene comune, la partecipazione, la proprietà privata, la destinazione universale dei beni assicurano la dimensione umanistica al cambiamento digitale.
Nel maggio di quest’anno (2018) l’Unione Europea dovrebbe rendere normative le indicazioni per la riservatezza dei dati, per evitare che operatori industriali, stati e grandi centrali dei sistemi comunicativi pieghino ad interessi privati e manipolino l’enorme patrimonio di dati personali raccolti attraverso il commercio, l’amministrazione pubblica e strumenti come lo smartphon.
L’Arbeitihlfen 288 specifica ulteriormente alcune delle sfide maggiori come il diritto alla condivisione. Figure marginali come i disoccupati o gli immigrati non possono essere esclusi. La comunicazione digitale potrebbe favorire la partecipazione politica, ma non può certo sostituire la rappresentatività democratica. Va inoltre sottolineato il diritto d’autore o la proprietà intellettuale. Il piano delle relazioni amicali e immediate non va confuso con quello professionale e artistico. La cultura del gratuito non deve diventare quella delle «copie a sbafo».
Di particolare rilievo è la cura educativa dei bambini e dei giovani nell’uso delle nuove tecnologie. Quanti hanno compiti educativi non possono sottrarsi alla competenza mediale per essere efficaci nell’indirizzare all’uso responsabile e consapevole dei mezzi. La violenza e l’odio a cui i social danno spazio sono un ulteriore motivo di preoccupazione. Essi producono polarizzazioni e divisioni non favorevoli a un confronto civile. Soprattutto se prende forma la legittimazione o il mancato controllo delle false comunicazioni.
Post-verità e “senso”
La discussione pubblica sulla «post-verità» mette in questione la compatibilità della cultura web al tema della verità e, più in generale, alla «volontà di dire il vero», la «veridizione». «L’assenza di dimensione verticale in una cultura numerica fondata sul modello della rete sembra rimuovere la base di ogni verità» (Documents, p. 22). Ma se niente prova la veracità di un’affermazione, è difficile pensare che sia venuto meno la pretesa di dire la verità. Ciò che è cambiato sono i modi di riconoscimento della verità. Essa non è più una forza sociale, uno strumento politico, un messaggio istituzionale dominante. Richiede un’altra autorità. Non quella della rivelazione dall’alto, non quella dell’autorità umana (i maestri), ma quella della pertinenza riconosciuta dai pari. Mentre la verità può essere indicata come adequatio rei et intellectus (conformità della cosa e dell’intelletto), la pertinenza, nozione tipica della cultura numerica, è l’adeguazione fra i contenuti proposti e le attese espresse o no da ciascun internauta.
Una sfida di rilievo. Le condizioni personali (individualismo, bolla di auto-riconoscimento, assenza di confronto diretto) e quelli sociali (le piattaforme numeriche non sono interessate al vero, ma ai profitti commerciali della vendita dei dati personali) non impediscono una trasmissione veritativa nella rete, anche attraverso forme come il riso, l’arte, le emozioni, le immagini e il gioco, estranee al tradizionale insegnamento intellettuale.
Se l’appello agli argomenti di autorità perde senso, non così la forma del dialogo. Esso diventa interlocuzione esigente, risposta alle questioni che attraversano gli interlocutori. Un contesto che permette anche la riproposta della verticalità della verità, della sua trascendenza.
Tutto ciò comporta non solo un aggiornamento degli strumenti, ma una diversa modalità di partecipazione nella rete. Nel libro Di terra e di cielo si indicano alcuni elementi della pastorale che sono investiti dalla cultura numerica come la comunicazione visuale, i social, i media education, gli uffici stampa, gli animatori della comunicazione, il cinema e le sale della comunità.
Più in profondità è da prevedere una rinnovata inventività laicale, una disponibilità a giocare le proprie idee nel mercato informativo, trasformando l’istituzione in risorsa e non in un freno.
Può anche succedere che l’era numerica alimenti una pastorale «come laboratorio della ripartizione dell’autorità, del potere e dell’obbedienza». «Per il cattolicesimo ci sono grandi possibilità, mettendo a disposizione le infinite risorse di cui dispone nel suo patrimonio culturale, spirituale e mistico. Avrebbe tutta la legittimità di presentarsi come religione dell’intelligenza, dello studio e del dialogo interculturale. Al contrario di una presentazione cristiano-cattolica in rete che l’accantona in una posizione devota, moralistica e autosufficiente, mentre essa ha saputo sviluppare una intelligenza della fede e del mondo che potrebbe stupire la tarda modernità avida di “senso”» (Documents, p. 37).