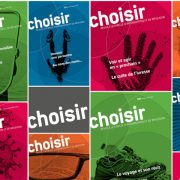Squid Game (오징어 게임, Ojing-eo geim, lett. “Gioco del calamaro”) è una serie televisiva sudcoreana ideata, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, distribuita da Netflix dal 17 settembre 2021 al 27 giugno 2025, articolata in tre stagioni e ventidue episodi. Una narrazione cruda, disturbante e coinvolgente, che ha scosso milioni di spettatori in tutto il mondo.
Il suo successo planetario è andato ben oltre la fascinazione estetica: Squid Game ha intercettato un disagio globale, trasformando una distopia violenta in uno specchio dell’anima sociale contemporanea.
Con la recente uscita della terza stagione si riapre una domanda che accompagna la serie fin dall’inizio: che cosa siamo disposti a sacrificare per sopravvivere? E, soprattutto: quali dinamiche di potere ci spingono a umiliare, manipolare, distruggere l’altro per salvarci da soli?
Sorprende, per chi guarda con occhio critico, la somiglianza inquietante tra il meccanismo narrativo di Squid Game e un esperimento scientifico realmente accaduto: l’esperimento carcerario di Stanford, condotto nel 1971 dallo psicologo sociale Philip Zimbardo.
Due realtà – una immaginata e l’altra empirica – che finiscono per raccontare lo stesso nodo antropologico: quando la libertà viene sospesa e il contesto è strutturato secondo logiche di dominio, anche l’individuo più ordinario può trasformarsi in carnefice o vittima.
La logica del “gioco”: tra controllo, bisogno e umiliazione
In Squid Game, persone fortemente indebitate accettano di partecipare a una serie di giochi infantili letali nella speranza di vincere un montepremi miliardario. Il contesto è esteticamente surreale – tute colorate, labirinti geometrici, soldati mascherati – ma la tensione morale è realissima. I giocatori sono messi l’uno contro l’altro, e ogni partita diventa una sfida non solo per la sopravvivenza, ma per il senso stesso dell’umanità.
Dietro le regole ferree del “gioco” si cela una verità brutale: non esiste una via di uscita collettiva, ma solo la salvezza del singolo a scapito degli altri. Solidarietà, empatia, giustizia sono valori residuali, destinati a essere schiacciati dalla paura e dal bisogno.
Questo meccanismo è sorprendentemente simile a ciò che accadde all’Università di Stanford.
L’esperimento carcerario di Stanford (Stanford Prison Experiment) fu condotto nel seminterrato dell’edificio Jordan Hall, sede del Dipartimento di Psicologia dell’Università di Stanford, in California. Ventiquattro studenti, divisi arbitrariamente in “guardie” e “prigionieri”, iniziarono a comportarsi in modo sempre più autoritario o sottomesso. In pochi giorni, le guardie divennero sadiche, i prigionieri depressi, e l’esperimento fu interrotto prima del previsto. Non fu la malvagità personale a generare violenza, ma la struttura stessa del gioco, le sue regole, il potere dato senza responsabilità.
Finzione e realtà: cosa ci dice tutto questo?
L’accostamento tra Squid Game e l’esperimento di Stanford non è solo suggestivo, ma illuminante. Entrambe le situazioni mostrano come le condizioni esterne – e non solo le inclinazioni personali – determinino il comportamento umano. Non siamo individui del tutto liberi, ma profondamente influenzabili. In certe condizioni, chiunque può diventare carnefice. E chiunque può essere sacrificato.
La serie, come l’esperimento, ci spinge a riflettere su un nodo etico centrale: quanto vale una vita? E cosa succede a una società – o a una persona – quando l’unico metro di valore diventa il denaro o il potere?
In questo senso, Squid Game non è solo una denuncia sociale, ma anche una parabola moderna. Ci ricorda che ogni sistema che premia la competizione cieca e l’isolamento etico produce mostri. E che dietro la spettacolarizzazione del dolore – oggi ampiamente consumata sui media – si nasconde una domanda di senso che le nostre culture non possono più ignorare.
La legge di Yerkes-Dodson e la pressione psicologica
La Yerkes-Dodson Law afferma che un moderato livello di pressione migliora la performance, ma un’eccessiva pressione la distrugge. In Squid Game, i partecipanti giocano sotto minaccia di morte: la performance diventa una questione di vita o di morte. Il gioco del biscotto dalgona, ad esempio, trasforma un compito semplice in un’impresa quasi impossibile, a causa dello stress e della paura.
Come sottolinea Alan Jern su Psychology Today (2021), la curva della performance è spinta oltre il limite: “se la pressione è troppo grande, potresti crollare e iniziare a fare errori che normalmente non faresti”. La serie mostra così il paradosso tragico della società contemporanea, in cui le persone sono spinte al limite per sopravvivere economicamente, psicologicamente, moralmente.
Deindividuazione e identità sociale
I sorveglianti del gioco indossano tute rosse e maschere che annullano ogni identità personale. Questo meccanismo riflette il fenomeno della deindividuazione, secondo la teoria dell’identità sociale: quando l’individuo si sente anonimo, tende a conformarsi alle norme del gruppo, anche se violente o immorali.
Un esperimento citato da Jern (riprendendo Reicher) mostra che l’anonimato può rafforzare l’obbedienza ai codici del gruppo più che ai valori personali.
L’assenza di legami e il fallimento della solidarietà
Uno degli aspetti più dolorosi della serie è la sistematica distruzione dei legami umani. Anche dove nascono affetti (come tra Gi-hun e l’anziano Oh Il-nam, o tra i personaggi femminili), il gioco costringe a tradire o uccidere l’altro per avanzare. In questo senso, Squid Game è una metafora cupa della società ipercompetitiva, in cui ogni legame è subordinato alla logica della prestazione.
Eppure, proprio nei momenti di solidarietà inattesa – il sacrificio di Ali, la scelta di rinunciare a vincere di Gi-hun – emergono i segni di un’umanità non completamente perduta. Sono brecce spirituali che aprono alla domanda: è possibile un altro modo di vivere? È possibile salvarsi, oltre che sopravvivere?
La religione che sopravvive tra le macerie
La Bibbia conosce bene la dimensione della prova. Giobbe, tentato e privato di tutto, rimane figura emblematica della fedeltà nel dolore. Anche Gesù, nel deserto, affronta la tentazione del potere, del dominio, della fuga dalla croce. In Squid Game, i personaggi affrontano prove che mettono in luce il loro cuore: spesso corrotto, talvolta redento.
La violenza sistemica, la logica del profitto ad ogni costo, l’abbandono degli ultimi sono tratti di una “cultura dello scarto” che la serie esaspera per denunciarla. Eppure, nella figura di Gi-hun e di pochi altri, emerge una speranza: la possibilità di una coscienza critica, di una ribellione etica, di un riscatto personale. È la stessa possibilità che, nella prospettiva cristiana, si apre a ogni uomo che “rientra in sé” (Lc 15,17) e sceglie di non cedere all’istinto, ma alla grazia.
In un universo apparentemente privo di Dio, alcuni personaggi mantengono una relazione personale con il sacro, a volte disperata, a volte sincera. Tra questi, spicca il giocatore 244, un uomo di fede (forse un pastore?), che, prima dei giochi, prega per sé e per gli altri. In un dialogo toccante con Ji-yeong afferma:
«Anima triste e smarrita. Cosa diresti di tutti coloro che oggi sono stati crocifissi per la nostra salvezza? Si sono sacrificati per noi. Siamo qui grazie al loro sangue. Io prego il Signore a nome di tutti noi peccatori. Rendo grazie per il loro sacrificio. Dio ha deciso di aiutare la nostra squadra a vincere. È per questo che siamo tutti qui».
Il suo linguaggio è chiaramente cristiano: parla di peccato, sacrificio, sangue redentivo, provvidenza. In un mondo svuotato di senso, 244 è testimone di una speranza religiosa che non si spegne, anche se decontestualizzata o forse illusa.
In modo simile, nell’ultima scena della prima stagione, un predicatore solitario con una croce rossa annuncia la salvezza nel mezzo di una strada caotica, mentre Gi-hun, ferito e bendato, giace a terra. Questa immagine evoca il Buon Samaritano (Lc 10,25-37), ma anche il disinteresse del mondo moderno verso la salvezza e la Parola, oggi ridotte a rumore di fondo.
Conclusione: un monito per il nostro tempo
Se Squid Game ci affascina, è perché ci riconosciamo. Non certo nei giochi mortali, ma nel bisogno di essere visti, salvati, liberati dal peso della colpa o della povertà. E se l’esperimento di Stanford ci disturba, è perché mostra che la violenza non è un’eccezione della storia, ma una possibilità sempre in agguato.
Per questo, la finzione può diventare rivelazione. E un’analisi culturale, anche a partire da una serie Netflix, può aprire spazi di pensiero, di dialogo, perfino di conversione etica e spirituale.
In fondo, come ricordava Hannah Arendt, «il male non è radicale: è banale. È figlio dell’irriflessione». Squid Game ci chiede, in ultima istanza, di non chiudere gli occhi.