
Intervista di Giordano Cavallari al giornalista Nello Scavo, inviato di guerra del quotidiano Avvenire, autore del recente volume Kiev (Garzanti, Milano 2022).
- Nello, dove sei stato in questa tua ultima missione giornalistica?
Ho percorso soprattutto il sud dell’Ucraina, nella zona rivolta al Mar Nero: da Odessa verso la Transnitria ad ovest, verso Kherson, ad est, soffermandomi al centro della zona, cioè a Mykolaïv.
- Con quale criterio ti sei spostato?
Ho voluto andare innanzitutto nei territori di Kherson appena liberati dall’occupazione russa. Avevo istituito contatti nel periodo dell’occupazione: alcune persone mi avevano fornito informazioni dall’interno. Volevo quindi conoscere direttamente la situazione. Mi ha interessato capire com’è cambiata la guerra da quelle parti.
Kherson è stata liberata dalla presenza militare russa, ma questa s’è attestata appena al di là del fiume Dnipro e da là “martella” la città e i villaggi abitati, non solo con i missili, ma anche con l’artiglieria. In precedenza, l’impiego dell’artiglieria ha riguardato prevalentemente il confronto tra i due eserciti. Ora l’artiglieria batte sistematicamente la popolazione civile, specie nei punti di maggiore frequentazione. Ho cercato di documentare tutto questo.
Ho cercato inoltre di raccontare che cosa resta in un territorio dopo la ritirata dei militari russi. Conoscevo già i loro metodi dalle precedenti guerre: mi sono ritrovato a contare i cadaveri abbandonati sulle strade.
Muoversi per raccontare
- Da giornalista, quanto sei stato libero di muoverti?
Francamente non ho mai vissuto tanta libertà di movimento in zone di guerra come in Ucraina. Come tutti i giornalisti, sono stato dotato di un permesso per potermi spostare. La categoria degli inviati di guerra è normata dal diritto internazionale. Il pass per giornalisti può essere fornito solo dallo stato maggiore dell’esercito del Paese in guerra. Il 21 febbraio mi trovavo già in Ucraina e ho ottenuto il permesso il 24 dello stesso mese, ossia subito dopo l’aggressione russa e l’inizio della guerra.
Col permesso ho potuto decidere dove andare, spostandomi con i mezzi pubblici − treni e bus − oppure con i mezzi di privati o di amici, solo o assieme ad altri giornalisti: del The Guardian, ad esempio, piuttosto che della RAI.
Naturalmente, sono sempre tenuto ad osservare le regole elementari dettate da ogni Paese in guerra: ad esempio, se viene colpita una struttura considerata strategica, non posso avvicinarmi alla stessa, per fare cronache, ma le foto vanno pubblicate dopo 12 ore (per quanto questo possa apparire oggi pleonastico alla luce delle ininterrotte riprese satellitari). L’altra limitazione scontata è l’osservanza delle ore di coprifuoco: limitazione che riguarda ogni cittadino; anzi, noi giornalisti, abbiamo la facoltà di muoverci anche di notte, se ciò è giustificato da interessi mediatici riconosciuti, quali nuovi bombardamenti.
Quel che voglio chiarire − anche a fronte di qualche deformazione − è che, in questi 9 mesi di guerra in Ucraina, non sono mai stato accompagnato da militari e i militari ucraini non mi hanno mai detto dove dovessi andare. Certamente i militari stabiliscono limiti, anche ai giornalisti, con cordoni e punti di controllo invalicabili.
Sono stato al fronte anche dentro le trincee, a testimonianza della libertà di cui ho fruito.
Non altrettanto penso possano dire i giornalisti che si sono mossi dall’altra parte, nel Donbass controllato dai russi: là è più difficile ottenere i permessi, sia perché chi è accreditato dalla parte ucraina non viene accreditato dalla parte russa (e viceversa), ma soprattutto perché chi va nel Donbass deve essere accompagnato sempre dai militari russi, per evidenti ragioni di racconto ad una sola direzione.
Libertà di movimento del giornalista non significa tuttavia facilità di accesso a tutte le informazioni. È chiaro che le informazioni ufficiali, in tempo di guerra, sono centellinate, calcolate, orientate. Non ce lo nascondiamo: la propaganda è all’opera sia da una parte che dall’altra.
- Il giornalista “inviato di guerra” − fatto in questo modo − corre bei rischi: perché farlo?
Penso che, se non si vuole correre rischi, non si possa fare il corrispondente di guerra. Ciò non vuol dire vivere il mestiere con superficialità né spavalderia, anzi, la consapevolezza del rischio e il sentimento della paura sono elementi essenziali del mestiere.
- Hai qualche episodio da raccontare?
Mi è capitato durante una diretta del TG3 di trovarmi tra i missili ipersonici russi che stavano cadendo e le forze ucraine che stavano reagendo sparando nella nostra direzione coi kalashnikov per abbattere i missili (cosa di per sé senza senso): ora sono qui a raccontarlo.
Altre volte mi sono trovato coi bombardamenti a poche centinaia di metri. Questo è per dire che, per quanta accortezza si abbia, il rischio − in questa guerra − può essere sempre vicino: i russi non avvisano quando e dove lanciano i missili.
- Non provi paura nel fare questo mestiere?
Penso che la paura sia una compagna di viaggio dei buoni giornalisti. La paura funge da protezione e da dissuasione da certi propositi. Ad esempio, come ti ho detto, ora le truppe russe che si sono ritirate dalla città di Kherson, la stanno bersagliando con l’artiglieria dall’altra sponda del fiume Dnipro: questo vuol dire che sparano nel mucchio senza precisione.
Le bombe a grappolo lasciano poi, su una vasta area di terreno, centinaia di bossoli inesplosi, pronti a deflagrare quando calpestati o schiacciati da un veicolo, come è già capitato a qualche giornalista. La paura aiuta a tenersi lontani, per quanto possibile, da queste situazioni.
Come diceva il famoso fotografo di guerra Robert Capa, la posta in gioco per un corrispondente, prima della notizia, è la sua stessa vita. L’ho ben presente.
Giornalismo di guerra
- Dove hai dormito in Ucraina? Come hai vissuto?
Come altri giornalisti ho tenuto qualche albergo per riferimento. Nell’ultima missione ho preso una stanza in un albergo di Odessa. Di solito si prenota l’hotel, anche per un periodo piuttosto lungo, quale base di appoggio, ma poi ci si muove come ho detto e quindi si dorme e si vive come capita. Mi è capitato perciò di dormire nei bunker, insieme alla gente, oppure nelle case, ospitato da famiglie ucraine.
Tieni conto poi che, nella situazione che si è ingenerata, molti alberghi hanno chiuso da un giorno all’altro, ad Odessa come a Kiev, per mancanza di corrente elettrica, acqua, forniture; altri reggono con i gruppi elettrogeni e hanno persino l’acqua calda e il riscaldamento: un vero lusso di questi tempi. Quando mi sono trovato ancora in alberghi di questo tipo, ho pensato alla popolazione che affronta disagi ben superiori e crescenti. Neppure la condizione di vita di noi giornalisti in Ucraina è facile, ma c’è ben di peggio.
Per poter dare seguito al nostro lavoro, abbiamo bisogno di una sola cosa, indispensabile: i collegamenti per mandare i servizi da tablet e cellulari in Italia. Ma questa garanzia non c’è più in Ucraina. Perciò ci si deve appoggiare spesso alla rete internet satellitare «donata» da Elon Musk.
- Come sono visti i giornalisti dalla gente in Ucraina?
Stare in mezzo alla gente del posto è di fondamentale importanza per un giornalista. Si colgono notizie che solo più tardi arrivano a livello ufficiale oppure non arrivano affatto. Si colgono naturalmente gli umori. D’altra parte, la gente avverte la presenza dei giornalisti come importante e necessaria. Chi ci conosce ormai da tempo ci chiede di non andarcene, di restare a raccontare i crimini che hanno subìto, i loro sentimenti, i pericoli e i problemi che stanno vivendo ogni giorno.
Racconto, in proposito, un episodio commovente e significativo accaduto nelle settimane scorse: in un villaggio appena liberato dalla presenza dei militari russi è entrata una troupe di giornalisti; i vecchietti hanno creduto che fossero militari ucraini senza divisa e stavano preparando i fucili sottratti ai russi per regalarli ai «liberatori»; quando hanno capito che si trattava di giornalisti stranieri hanno cominciato ad apparecchiare e ad invitare tutti a tavola. Quella gente ha tanta voglia di raccontare e di raccontarsi.
- Qual è l’atteggiamento delle autorità ucraine verso i giornalisti?
I controlli di rito sono assai severi, marziali. Il timore che il giornalista possa essere un testimone scomodo o, comunque, un seccatore, c’è. Col tempo − se si resta o si ritorna − la diffidenza si scioglie e i rapporti possono diventare amichevoli.
Penso si sia insediata nella popolazione, a tutti i livelli, la convinzione che la presenza dei giornalisti sia in grado di scongiurare i più gravi crimini. Non so se questo sia proprio vero. Sta di fatto che, nei villaggi in cui sono avvenuti i crimini più efferati, non c’erano giornalisti. Così come è accertato il fatto che, dalle città occupate, i giornalisti ucraini abbiano dovuto fuggire perché tra i primi ricercati dagli occupanti russi.
Guerra e sentimenti
- Ci sono collaborazionisti dei russi tra gli ucraini? Ne hai scritto nei tuoi articoli.
Ho scritto che ci sono indagini in corso. Penso che si debba andare molto cauti nel parlare di «collaborazionisti». Il mio timore è che − sotto la spinta emotiva − con questa etichetta, passino persone che non c’entrano nulla con la delazione o col cambio di casacca.
Aver offerto un pezzo di pane ad un soldato russo o avergli offerto qualche informazione di sopravvivenza, magari estorta con la minaccia, non basta per portare a quella classificazione.
- Gli umori e i sentimenti della gente che hai incontrato quali sono nei confronti della Russia e dei russi?
Tutti mi sembrano ancora intenzionati a resistere all’aggressione, senza cedimenti. C’è, tuttavia, secondo me, differenza di pensiero tra la popolazione di una certa età e i giovani adulti ucraini: i più anziani sono stati forgiati da oltre 70 anni di dittatura e propaganda di regime sovietico e appaiono quindi meno assertivi contro Mosca, al punto da condividere, almeno alcuni, la critica alla «modernità» occidentale; mentre i più giovani − dai 50 in giù − non vedono alcuna ragione, neppure remota, per giustificare le mosse del Cremlino.
- Anche dalle parti del Donbass, la pensano così?
Come ho scritto nel libro, il Donbass è stato − da noi occidentali − dimenticato in questi anni. Eppure, si stava combattendo, dal 2014, una guerra che aveva già fatto 14.000 morti tra combattenti e civili. Il territorio, nel mentre, è ancor più impoverito. La Russia è apparsa come una «fascinazione», se così si può dire, per parte della popolazione del Donbass, pur di uscire da una situazione così prolungata e difficile. Teniamo poi in considerazione il fatto che molte famiglie del Donbass hanno origine territoriale russa, con parenti in Russia.
Ciò che mi sembra di aver notato, con una certa sicurezza, è che anche i filorussi hanno mutato e stanno mutando atteggiamento verso la Russia: molti pensano che sia necessario un negoziato piuttosto di continuare la guerra in questo modo. Diventa sempre più evidente che la Russia sta distruggendo il Donbass e che − a chi sta al Cremlino − non interessa nulla di loro e delle loro vite, perché interessa solo la terra, le sue risorse e la politica internazionale.
- La popolazione ucraina, al di qua del Donbass, non è stanca? Non vorrebbe il negoziato, ora?
Certamente la popolazione ucraina è stanca, soffre i continui blackout, il freddo, le condizioni di vita sempre più dure. E tuttavia alla domanda: «Non pensate che sia giunto il momento di trattare?», la risposta è: «No, è il momento di intensificare la resistenza».
Sono andato pure alla ricerca di ucraini che la pensano in maniera diversa, ma, a parte i gruppi pacifisti − che hanno una posizione nobilissima sulla resistenza disarmata −, non ho trovato nessuno.
Abbiamo interpellato la comunità ebraica, chiedendo se si sente minacciata dalle formazioni combattenti ucraine di estrema destra, ma questa ci ha detto di non avvertire antisemitismo oggi in Ucraina e di non giustificare le accuse putiniane di nazismo all’Ucraina. Abbiamo interpellato poi i circoli della sinistra radicale intellettuale − che senz’altro propugna un mondo senza armi −, ma anche da questi abbiamo raccolto la voce della difesa necessaria, con le armi.
- Dal mio punto di vista, risulta difficile comprendere tanta determinazione…
Mi rendo conto che, stando in Italia, non si riesce a capire sino in fondo lo stato d’animo di questa gente. Si capisce solo stando là, in guerra, partecipando con la gente ucraina alla esumazione dei cadaveri e al riconoscimento dei segni della tortura, della violenza, dell’abuso.
Una commissione delle Nazioni Unite ha riconosciuto segni di stupro su cadaveri dai 4 a 82 anni. Soldati maschi hanno abusato di bambini maschi. Avevo raccolto voci di questo genere, ma ora ci sono le prove.
Ecco, quando vedi queste cose con i tuoi occhi, capisci perché, nonostante i blackout, nonostante il freddo, nonostante tutto, questa gente voglia resistere, con le armi, con tanta determinazione.
- Il governo di Zelensky sta quindi interpretando la volontà del popolo ucraino?
A me sembra evidente che non c’è stato alcun cambio di umore complessivo nella popolazione, sia nella condanna netta nei confronti della Russia di Putin, sia nel sostegno alle scelte del proprio governo.
Il fatto poi che il Cremlino abbia deciso di commettere un ulteriore crimine di guerra prendendo di mira tutte le strutture civili, lasciando gli ucraini al buio e al freddo, colpendo persino gli ospedali con i feriti e i malati, non può che aver incrementato i sentimenti di cui ho detto.
Le Chiese
- Parlare della gente significa anche parlare di fedeli appartenenti alle diverse Chiese: in tal senso, quali sono gli umori che hai raccolto?
Il sentimento che ho percepito − molto diffuso − è il senso di tradimento perpetrato da Kirill, il patriarca di Mosca. Non ignoriamo che la Chiesa ortodossa ucraina era legata a doppio filo all’ortodossia russa. Il legame profondo è rimasto nella gente comune anche dopo il riconoscimento della autocefalia alla nuova Chiesa.
Prima della guerra si poteva ancora parlare di complementarità tra le Chiese almeno a livello di popolo. Ora penso che non sia possibile. Le parole di Kirill hanno ferito profondamente il popolo ucraino e non possono essere dimenticate: sono parole di guerra contro lo stesso popolo.
- Le posizioni della nuova Chiesa ortodossa del primate Epifanio sono molto accese…
Quella Chiesa si sente indubbiamente una Chiesa militante, parte attiva della resistenza. È una Chiesa che si può definire martire: ha avuto cappellani arrestati e torturati dai russi. Conosco bene il caso di un pope cappellano militare sull’Isola dei Serpenti: Oleksander Chocov. Durante l’occupazione dell’isola è stato arrestato e torturato per 3 mesi.
È stato rilasciato per effetto di uno scambio di prigionieri mediato dal Vaticano. Al rilascio non ha parlato di torture ed è rimasto a lungo nel silenzio per facilitare il rilascio di altri prigionieri. Ma quando le truppe filorusse hanno distrutto la prigione di Olenivka, ove c’erano prigionieri ucraini, provocandone la morte, ha deciso di dire tutto. Mi ha dato copia della sua deposizione alle autorità ucraine e internazionali. Ha testimoniato quanto ha subito e quanto hanno subito altri prigionieri.
- Dentro la Chiesa ortodossa − di per sé ancora in comunione col patriarca di Mosca − il cui primate è Onufrij, quali sono le posizioni?
I preti di quella Chiesa sono ancora molto legati a Mosca, ma sono sicuro che molti pope hanno preso pubblicamente le distanze dalle posizioni del patriarca Kirill. Nell’aprile scorso un monastero facente capo alla Chiesa russa è stato bombardato dai russi, perché un pope e le religiose di quel monastero si erano chiaramente espresse contro la guerra di Putin e di Kirill.
- Come spieghi le perquisizioni dei servizi segreti ucraini in monasteri e diocesi della Chiesa ortodossa legata a Mosca, tra cui il Monastero delle Grotte di Kiev?
Le perquisizioni delle forze ucraine nei monasteri non sono evidentemente una bella cosa. Non sappiamo cosa sia stato trovato. Almeno io non lo so. Certamente i servizi segreti lavorano anche in Ucraina. Il segnale mi sembra eminentemente politico. Il governo − con la popolazione − non può tollerare che si sostenga che un’identità ucraina non esiste e che quindi non esiste una nazione ucraina. Queste sono le tesi di Putin e di Kirill. E si sa che in quei monasteri si fa ancora riferimento a Kirill e che con lui è rimasto aperto un canale di comunicazione. Ma tutti i pope e tutti i monaci di quella Chiesa non la pensano a quel modo.
Ti potrei portare molte testimonianze dirette di pope ortodossi che non hanno aderito alla Chiesa autocefala e che quindi sono ancora in comunione con Mosca. Questi mi hanno detto di vivere una doppia sofferenza: da una parte, si sentono traditi appunto dal patriarca, dall’altra, si sentono guardati con sospetto dai loro fedeli.
Una volta sono andato a trovare un pope al confine tra l’Ucraina e la Moldavia. Allo scoppio della guerra si è premurato di far arrivare sua moglie e i suoi figli in Italia, in cui vive una sorella. Mi ha detto che la scissione della Chiesa − ora autocefala − è avvenuta troppo in fretta. A suo dire la distinzione avrebbe potuto realizzarsi in maniera meno traumatica, col tempo. Perciò non se l’è sentita di aderire da subito. Ma di Kirill − lui − non vuol sentir parlare. La sua gente ha capito e continua a sostenerlo.
- Il comportamento del governo ucraino non risulta, in qualche modo, speculare a quello russo, in fatto di libertà di pensiero e di religione?
C’è una differenza evidente di comportamento che voglio far notare: mentre da parte ucraina, dopo le perquisizioni, nessun religioso è stato arrestato per le sue opinioni, dall’altra parte, ci si sono stati arresti e torture. È ben diverso.
- La Chiesa greco-cattolica quale testimonianza sta dando?
Proprio in questi giorni, l’esarcato greco-cattolico di Donetsk, nel Donbass, ha denunciato l’arresto e, probabilmente, le torture subite da due suoi preti. Questo nel momento in cui Putin fingeva di accogliere le proposte di mediazione vaticana per la pace.
Ogni fatto è collegato all’altro. Il mestiere del giornalista è saper collegare i fatti per comporre uno scenario. Secondo me, è impossibile che Putin non sapesse di questi due preti cattolici. Le sue dichiarazioni, quindi, sono state del tutto strumentali. Consapevolmente.
- I fedeli dove e come scelgono di frequentare il culto, in uno scenario così diviso e frammentato?
Dipende dai posti. Nei villaggi, in cui la frequentazione è maggiore e spesso c’è una sola chiesa, i fedeli continuano ad andare nella stessa chiesa, anche se rimasta in comunione con Mosca, ma solo se sanno che il loro pope ha preso le distanze dalle parole di Kirill. Conosco casi in cui ciò non è avvenuto e i fedeli non hanno più messo piede in chiesa. Nelle città il discorso è diverso. C’è minore frequentazione e i fedeli possono decidere dove andare.
C’è da aggiungere che andare in chiesa e partecipare al culto è divenuto persino − fisicamente − pericoloso in Ucraina. Qualche tempo fa, a Mikolaïv, è accaduto che fedeli ortodossi siano stati colpiti da un missile all’uscita dalla chiesa. In quella circostanza è morta una vecchietta che avevo conosciuto personalmente, molto cara anche ai giovani della Operazione Colomba della associazione Papa Giovanni XXIII impegnati a Mikolaïv.
- Le parrocchie e i monasteri vivono solo delle offerte dei fedeli: come si sostengono ora in Ucraina?
Nonostante le grandi difficoltà che sta vivendo la popolazione, i pope ortodossi e i preti cattolici che conosco non lamentano la mancanza del necessario per vivere. I fedeli continuano a sostenere le comunità religiose, anche quelle che non si sono separate nettamente da Mosca. Ma questo non vuol dire che i fedeli siano filorussi.
Come hai capito, in questa guerra, come del resto in tutte le guerre, c’è una grande complessità umana da raccontare. Le categorie da derby calcistico qui non funzionano e, se vengono usate, banalizzano il tutto. Più il tempo passa, più la complessità aumenta.
- Come hai scritto il tuo libro «Kiev»?
L’ho scritto a modo di diario di guerra, cercando di recuperare la forma dei dispacci usata dai corrispondenti di decenni fa. L’ho scritto con l’intento di spogliarmi di ogni aura mitica che possa circondare la figura dell’inviato di guerra, visto a volte come un superman, a volte come un incosciente.
L’ho scritto, soprattutto, «subito», ossia per fissare in memoria ciò che è accaduto sin dal primo momento − chi ha aggredito e chi è stato aggredito − con la consapevolezza che, col tempo, la complessità sarebbe aumentata e che presto si sarebbe potuta perdere per strada la «verità» iniziale.


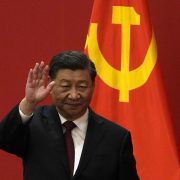



Interessante conoscere certe sfumature!