
Il poderoso volume L’uomo, evento dell’eccesso di Dio del teologo fondamentale Bertuletti, classe 1940, apprezzato per il rigore filosofico impresso alle ricerche della Facoltà teologica di Milano, segue (questa volta purtroppo senza un indice dei nomi) a Dio, il Mistero dell’Unico, 2014, prima imponente sintesi del suo pensiero.
I due testi (li indicheremo con UE e DM) vanno letti insieme e, secondo noi, partendo dal secondo, il quale si connota di una forma espositiva imprevista.
Un libro, un genere e la citazione
Quella del genere letterario non è del resto una questione periferica rispetto all’identità della disciplina “teologia”, che sperimenta – di volta in volta – i metodi argomentativi più idonei per riflettere criticamente sull’esperienza di fede in Gesù Cristo, icona visibile del Dio invisibile. Dalle Confessioni di Agostino alle Lettere di Bonhoeffer alle Summae medievali i teologi si sono misurati con i diversi stili che esprimono e corrispondono alla ricchezza inventiva delle Scritture, in cui domina il racconto, ma in cui si offrono apparati testuali differenti: indimenticabili esegesi (Gesù che spiega le sue parabole), testi poetici, normativi, sapienziali, oracolari, spesso ibridati tra loro, poichè la “cosa” di cui si parla e che si attesta e tramanda (la verità dell’unico Dio) ha una luminosità troppo forte. Occorre scandirne la ricchezza attraverso il prisma di uno scriba, che sappia mostrarne la policromia nascosta e i rimandi intrinseci.
Ebbene DM si concludeva con una lunga citazione di Ricoeur (DM 589-590) a proposito dello schematismo della speranza. La nozione di “visione di Dio” qualifica pienamente il compimento escatologico dell’uomo. Ne sono esempi quelle “esperienze di eternità”, che per Ricoeur documentano il darsi di un fuori-tempo, di un più-che-tempo (la nascita di un bambino, un vibrante gesto di amicizia) e che trovano il loro analogato principe nel Dio che ci ricorda e assieme si prende cura di noi.
A sua volta Ricoeur menziona Whitehead (Dio diviene e non “è”, non “sta”) e Hartshorne (se la memoria divina è segnata dalle esistenze umane che non sono più, allora queste ultime fanno una differenza in Dio stesso). Bertuletti commenta da teologo: il sapere della fede usa concetti, i quali però non sono né vuoti né nudi perché si rdicano in un’esperienza. I concetti sono strumenti per pensare l’evento della verità, cioè l’accadere a noi e per noi di una verità indeducibile e ultimativa.
Bertuletti conclude DM dando parola ad altri e quindi obbedendo alla complessità tematica e disciplinare da cui il suo testo era partito, sollecitando l’accensione di prospettive plurime. Del resto, come suggeriva Walter Benjamin (1892-1940) il nostro dire è un citare, è un già detto che, citandolo, si fa nostro.
Ebbene il volume UE dedica uno spazio inusuale alla citazione, segnalando quali siano i sentieri, lungo i quali la linea di ricerca teologica dovrebbe procedere. Su tutti domina Paul Beauchamp. Per molte pagine, il volume non è che una glossa al gesuita francese (1925-2001) e alla sua cifra interpretativa del testo biblico, una cifra segnata dalla valorizzazione dei simboli e dal rimando antropologico della Scrittura, piuttosto che da un metodo storico-critico rigidamente inteso.
Beauchamp e il suo tempo
Beauchamp (per come è letto da Bertuletti) si concede, nel suo Prologo “non-esegetico” a Compiere le Scritture (il secondo volume di L’uno e l’altro testamento), una doppia domanda “teorica”: che cos’è l’uomo che parla e che cos’è lo scritto. Ora, questa concessione è una scommessa, più che un passaggio argomentato. Barth se ne ritrarrebbe.
Per quanto siano brillanti e convincenti (per Bertuletti) le risposte del gesuita, esse muovono dal seguente azzardo: si può concedere un autonomo approccio filosofico in antropologia e si può allestire una teoria del racconto, prescindendo dalla Rivelazione, poichè in ogni caso è Dio che si rivela nella storia, nella creazione, nel pensiero e si rivela anche a chi non gli dà esplicito credito (UE 135).
Ci si dovrebbe dunque attendere risposte univoche nell’arena filosofica e in quella linguistica. Ma non è così, come lo stesso Bertuletti documenta nelle pagine successive, in cui viene ripresa la lezione di Levinas, di Ricoeur e di Marion. Severe contestazioni sono state effettivamente rivolte a questi autori (e più in genere all’indirizzo ermeneutico-fenomenologico) da molteplici protagonisti del pensiero continentale e analitico. Basti pensare ai decostruzionisti o a Dominique Janicaud (1977-2002) che non ha mai creduto alla svolta (tournant) teologia della fenomenologia francese.
Teniamo presente del resto che il confronto di Beauchamp con i testi biblici non ha mai potuto prescindere dal dibattito narratologico che lo ha preceduto, accompagnato e seguìto. Lo stesso Beauchamp menziona Bachtin, Frye e Todorov (UE 303). Per Ronald Barthes (1915-1980) la “morte dell’autore” portava con sé la demolizione della vecchia critica letteraria borghese. Queste tesi provocarono dure reazioni da parte della corrente esistenzialistica. L’influsso di Derrida (1930-2004) impose poi una revisione delle tradizionali opzioni strutturalistiche. Per converso il suo decostruzionismo e l’anti-fonocentrismo furono accusati di demolire e relativizzare le leggi semiotiche comunemente utilizzate.
Il punto è che, quando un esegeta interpreta, scopre che il testo rinvia a referenti così diversi, che la stessa nozione di racconto e quindi di narratologia viene a frantumarsi in ottiche confliggenti, come è prevedibile nel contesto eticamente pluralistico in cui viviamo. Non dimentichiamo che azione e testo, secondo Ricoeur, si scambiano le metafore e quindi una teoria del linguaggio (anche del linguaggio biblico) deve riconoscere l’incommensurabilità con altre tradizioni rivali, così come accade per la bioetica. Basti sfogliare un trattato recente di narratologia: nemmeno sulla parola “narrare” c’è accordo.
Dunque Beauchamp ha fatto una scelta (e la stessa l’ha compiuta Bertuletti scegliendo Beauchamp) e questa sua postura radicale andrebbe più frequentemente storicizzata e comparata con altre cifre esegetiche e teologiche. Altrimenti, presa in blocco, la cifra dell’apprezzato gesuita diventa stucchevole e improduttiva. In questo, la lealtà di Bertuletti ci viene in aiuto, esponendo direttamente alla nostra lettura i testi originari di Beauchamp. In questo modo vengono sconfessati quei predicatori alla buona, che se ne sono appropriati senza dichiararlo e a volte fraintendendolo.
Quale “eccesso” di Dio? Comunicazione, non causa
Sin dal titolo e dalla Prefazione, UE adotta una terminologia non innocente. “Eccesso” viene riferito a Dio, che dunque viene riconosciuto oltrepassare (excessus da excedĕre), andar fuori, andare oltre la misura consueta. C’è un “di più” in Dio. Viene alla mente “In sovrappiù” di Marion, edito nel 2001 (!), ove il surcroît è riferito ai fenomeni saturi, fra cui ci sarebbe appunto la Rivelazione cristiana. Ma che cos’è questo “di più”? – domandiamo. E rispetto a che cosa lo si misura come “troppo”, come “sovrabbondante”? Rispetto a quali attese e precomprensioni? Al primo patto mai revocato? Al senso comune che sarebbe proprio dell’homo metaphysicus?
No: il Cristo ci restituisce alla verità della prima creazione superandola, eccedendola. L’uomo è un evento, risponde Bertuletti, un evento che corrisponde a un Dio che eccede. L’uomo e-viene in forza di un’origine, che viene a sé non senza l’altro da sé. L’unicità della relazione trinitaria instaura un rapporto con l’alterità della creatura, mantenendo la differenza e assieme valorizzando, a sua volta, l’unicità dell’alleato umano, chiamato (e quindi autorizzato, nella sua singolare, insostituibile finitezza) a consentire all’amore che gli si rivela affidabilmente. L’essere umano non è quindi esterno al principio, che gratuitamente lo crea, accoglie, sostiene, redime e adotta a figlio.
Anzi, l’origine, eccedendo, ha posto nell’uomo il marchio della propria unicità: la libertà umana si esercita singolarmente poiché è alimentata dall’unicità della sua origine. La libertà vuole il tutto attraverso volizioni finite che rinviano simbolicamente al compimento sperato, un compimento che, dal suo futuro, fa appello al presente dell’uomo. Il Dio unico, che ospita al suo interno (come suo componente costitutivo) l’“alterità” dell’amore trinitario, accoglie in sé (senza assimilarla) l’alterità creaturale, singolare, finita, unica e attiva, capace di dare e non solo ricevere vita e amore.
Questa era appunto la tesi di DM: il modello del rapporto tra divino e umano non è quello causale (inteso come causa efficiente), ma quello di comunicazione e sinergia (1Cor 3,9: siamo collaboratori di Dio, campo ed edificio di Dio): l’umano, nel prendere Cristo a modello, pensa, agisce e vuole facendosi coinvolgere da Dio in queste operazioni. Come cosa ne viene? Non un effetto, ma un evento, il quale non ha altra causa se non dentro sé e risulta riconoscibile solo attraverso la trama di un racconto, non grazie a qualche sillogismo algebrico o qualche calcolo fisico. La Bibbia insegna che l’alterità dell’origine, rispetto ai viventi finiti, non è assolutezza, ma espansione, eccesso. Infatti si parla di “origine” come fonte di un genitivo (origine-di-qualcosa) e non come autosussistenza isolata.
Bertuletti trova in Beauchamp la dettagliata applicazione esegetica di uno schema che gli è caro: l’origine non è l’inizio, l’inizio è solo la figura di un compimento che verrà. Quando tale figura primordiale cade, allora la potenza dinamica dell’origine (che non ha né inizio né fine) si lascia percepire e descrivere attraverso il processo, in cui essa, prendendosi il suo tempo e ricevendo qualcosa dall’umano (che in Dio fa differenza), porta il dono a pienezza. Gesù (in cui l’origine s’identifica) anticipa il compimento delle promesse assicurando che tutto il processo sia presente nell’atto che lo termina. L’inizio però non è uno stadio superato, ma un presente continuamente rinnovato. La seconda creazione è quella vera, ma essa non può realizzarsi né venir compresa o sperata senza la prima (di cui la seconda è compimento) (UE 383). Per converso, la stessa idea primaria di creazione accede al suo senso solo nella seconda creazione (Beauchamp in UE, 251).
Questo modulo teologico somiglia al taglio esegetico proprio di Beauchamp. Il termine di un racconto opera sin dall’inizio, riceve apporti dal fruitore, sollecita comparazioni tra il prima e il dopo, statuisce un patto tra autore e lettore e rinvia a un “fuori-racconto”, a un oltre-la-fine, al vero incipit (che nel caso biblico è la vicenda di Gesù). Chi scrive, chi attesta, avverte che qualcuno o qualcosa lo chiama a scrivere e a vivere scrivendo, e gli dice: “voglio che tu sia”, “voglio che tu nasca a un nuovo linguaggio”. Il centro della scrittura/Scrittura è invisibile ed eccedente la “lettera” poichè è un punto unico d’attrazione, cui gli attanti e le azioni rinviano per guadagnare e conoscere il loro senso. La Bibbia è racconto totale e aperto, perché si consegna alla libertà del lettore, dell’interprete, del critico, del filosofo, che sentono il compito di pensare e diffondere la “buona notizia”.
L’eccesso di Dio dunque «e-viene», si fa evento nell’uomo, prendendosi il tempo della storia e del libro per rivelarsi a chi “lo va a vedere”. Non capiamo pertanto perché non si possa parzialmente valorizzare la “processualità”, che le Process Theologies ispirate a Whitehead congetturavano nella forma di un divenire divino. Ne parleremo anche più avanti. Se Dio si fa uomo e l’uomo Gesù (il Messia) cresce e impara e soffre, muore e viene risuscitato, qualche divenire va concesso. L’ipse rimane identico (come promessa di tenera benevolenza), ma l’idem cambia e si sottrae così all’idolatria, rimandando a un futuro in cui egli sarà tutto in tutti.
Il tema del male genuino, persistente e crudele (un tema che non è impostato da Bertuletti riferendolo all’origine divina del negativo, come ipotizzava invece Luigi Pareyson), resiste all’attribuzione univoca alla colpa umana (fosse pure del suo progenitore mitico, che pecca cedendo al serpente, ma pecca anche per inesperienza e per la confusa ambiguità del comando divino – UE 251). Ma allora, se Dio mette necessariamente in pericolo la sua creatura (UE, 502), non è proprio Dio l’origine (non la causa) della caduta? Giobbe chiama in causa direttamente Dio e innesca in Dio un movimento, un divenire: Dio scende a giudizio, mostra, parla, difende il querelante, si mostra come il goèl autentico che rimedierà (nel tempo futuro) alla polvere e cenere che Giobbe giustamente continua a rifiutare (nel tempo presente).
L’invenzione del soggetto
Il secondo auctor maior di UE è Alain De Libera, il 77enne storico della filosofia medioevale, secondo il quale la teologia cristiana antica e medioevale avrebbe inventato il soggetto (cioè l’agente morale capace di pensiero e volizione autonome) ben prima che la modernità lo identificasse con il cogito e l’autodeterminazione individuale (entrambi senza Dio). Ad Agostino e Tommaso soprattutto andrebbe attribuito il prezioso scavo teorico, grazie a cui l’”ipostasi” divenne cifra privilegiata, al posto della categoria di substrato o supporto o supposito o sostanza aristotelica (capace soltanto di capacità passive e ricettive, quali attributi di un ente), per nominare l’umano.
Dal concetto biblico di creazione i pensatori cristiani trassero la convinzione che una dimensione antropologica appartiene-al (è inscritta-nel) piano originario (l’origine fa l’uomo a propria immagine) e che gli atti mentali esistono nell’anima come l’anima stessa (e non come suoi momenti performativi o come facoltà transitoriamente espresse). L’anima non è causa efficiente dell’atto di pensiero. E’ l’anima stessa che pensa, che cioè è l’atto di pensiero (UE, 539). Si tratta di un modello “pericoretico”, che rintraccia nella vita della Trinità quel “tutto in tutti” e quel “tutti in ciascuno” che identifica una relazione tra polarità che sono la stessa sostanza. Hypostasis è il nome della sostanza prima individuale (la persona, di cui materia e forma, corpo e anima sono elementi), che singolarmente e imprevedibilmente pensa e decide di sé, degli altri, di Dio. L’ipostasi non è quindi il prodotto di un’emanazione necessaria e necessitante, che escluderebbe sia la libertà dell’atto creativo divino sia la novità irriducibile del mondo sia l’arbitrio umano.
Conseguenza storiografica. L’archeologia del soggetto (diversamente da come la intendeva Foucault) dovrebbe essere un’archeologia della ragione teologica! La reificazione dell’ipostasi a ente sussistente (Vorhandene) costituì purtroppo il passo regressivo dell’antropologia metafisica, che aveva ormai perso la nozione di singolarità dell’io. Lasciamo ai medievalisti il compito di discutere questa lettura. Facciamo solo un esempio di palese e irrisolta controversia. La teoria di Putallaz a favore di una coscienza immediata di sé (UE 38) contrasta con quella di neotomisti (come Sofia Vanni Rovighi nelle sue celebri Istituzioni di Filosofia, 1982, p. 22) che negano all’io un’immediata autocoscienza: la conoscenza è originariamente presenza intenzionale di cose altre da me; l’io è dato immediatamente (soltanto) come soggetto degli stati affettivi e delle volizioni; sapere di conoscere è un’acquisizione riflessiva, quindi mediata.
Altro punto aperto è la volizione: Dio dà l’influsso perché la volontà voglia, ma è la volontà soggettiva che si determina e si specifica (Tommaso in UE 106). Dio vuole che la volontà voglia, ma non vuole (non obbliga) che voglia una certa cosa. Ora può una causa, come quella divina, muovere infallibilmente senza determinare il proprio effetto? Per uscire dall’impasse Tommaso postula due tempi della mozione divina: il primo sarebbe vòlto genericamente al bene, il secondo (riservato per grazia) sarebbe indirizzato all’esercizio particolare del volere. Anche in questa affermazione giocherebbe un ruolo decisivo l’influsso della fede cristiana (UE, 111). Il dibattito è aperto.
Fare teologia filosofando
Un tema interessante, che fa da corollario alle premesse sopraindicate, è l’innesco dell’interrogazione filosofica all’interno del lavoro esegetico e quindi nel contesto dell’ermeneutica scritturale e quindi necessariamente della cosiddetta teologia biblica (posto che questo termine significhi ancora qualcosa, dato che, nel caso cristiano, o la teologia è biblica o non è teologia). L’esegesi, emancipandosi dalla dogmatica, assumerebbe dentro di sé la pratica filosofica (UE 68). Come ciò può avvenire?
La giustificazione dell’assetto disciplinare noto come “Teologia filosofica”, se non vuol essere la mera amplificazione retorica della nozione di “sapere della fede” (genitivo soggettivo), si radica (così ritiene Bertuletti) nell’apertura incondizionata della coscienza umana verso l’assoluto. La coscienza è creata con questa qualità riposta nel segreto di ogni io. L’implacabile interrogazione e la spregiudicatezza, che connotano il filosofare, sarebbero pertanto alimentate dal perenne nascondimento (dalla riserva semantica, direbbe Heidegger) in cui e da cui Dio si mostra da sé quale Dio, come e quando egli vuole. Dio invita a pensarlo filosoficamente, mentre lo si invoca, e a raccontarlo da capo, ancora una volta, a partire dalla situazione storico-culturale del credente (una categoria – quella del narrare – pienamente riabilitata dalla teologia fondamentale e non più delegata a una corrente secondaria, detta in passato “teologia narrativa”).
Infatti, poiché Dio ha dato alla rivelazione la forma della storia, e non quella della sintesi filosofica (Lagrange in UE 67), Dio chiama il credente a ripercorrere la stessa via, percorsa da lui, per raggiungerlo. Gesù narra, sapendosi narrato “secondo le Scritture” e fa dei discepoli dei narratari, che vanno avanti e indietro nella comprensione dei testi sacri, come interpreti e narratori loro stessi. Si parva licet, nella nostra teologia del cinema (genitivo soggettivo) abbiamo pensato Dio come il racconto, l’archè di ogni racconto per immagini-in-movimento, che non solo si lascia narrare in nuove sceneggiature, ma che esige di essere narrato, è interessato a venire “filmato”, poiché quella del narrare è una modalità estetica dell’aver cura di lui, una cura di cui egli ha desiderio e “bisogno”.
Torniamo alla filosofia dentro alla teologia. Una giustificazione della teologia “filosofica” quale specifico settore scientifico-disciplinare (uso volutamente termini accademici) sarebbe questa: dato che l’umano è (in forza della fede in Gesù Cristo) l’unica figura disponibile per nominare Dio, un’antropologia fondamentale svolta sine fide (in altri termini, un’ontologia della libertà) costituirebbe un preambulum legittimo, prima-di e per introdursi in un’esegesi biblica (questa volta cum fide).
Si potrebbe ribattere che se si ossequiano i tradizionali criteri filosofici della verità (l’evidenza, l’inferenza e il dubbio metodico), si rinuncia a ogni convinzione interiore mentre si argomenta razionalmente. La stessa fede cristiana è messa tra parentesi e si ragiona etsi Deus non daretur. Il che è un passo indietro rispetto a Barth, poiché si prescinde dalla Parola e dalla fede in quella Parola, che sconvolge ogni presupposto “razionale” e categoria lessicale in tema antropologico.
Dove approda l’antropologia filosofica, svolta in sede teologica? 1. Al disegno di un atlante delle posizioni sostenute in tema di “homo” nella storia della filosofia. Oppure (caso più ottimistico) 2. alla dimostrazione di alcuni tratti dell’umano, ad esempio al riconoscimento della sua trascendentale aspirazione all’incondizionato, sul piano cognitivo o volitivo (come tentò di indicare Karl Rahner), oppure all’attribuzione al Dasein di alcuni caratteri “esistenziali” (come nel caso del primo Heidegger, che in sede teologica furono ripresi da Bultmann).
Altro la filosofia non offre, poiché essa deve limitarsi a constatare evidenze non contraddittorie e incontrovertibili (la fenomenologia) oppure a congetturare (a partire da ciò che è dato) una realtà che non è data, ma che è necessaria a rendere intelleggibile ciò che è dato (l’aspetto inferenziale). Il punto è che le diverse correnti della fenomenologia contemporanea (Heidegger critico di Husserl, Marion critico di Heidegger, Levinas critico persino del primato della teoresi) hanno invece mostrato che nemmeno le evidenze prime (i principi generalissimi della fenomenologia) sono univoche e indubitabili. E con questo si torna al caso 1, quello dell’atlante.
Forse una strada percorribile dal “teologo-filosofo” (che non voglia cadere in un banale ossimoro) potrebbe essere quella di consolidare la lezione proveniente da pensatori come il grande Karl Jaspers (non citato in DM), i quali sostengono che anche in filosofia è al lavoro una fede. Si tratta di una fede filosofica, cioè di una cifra originale a partire da cui l’esistenza legge la trascendenza. Un simile stile discorsivo è praticato anche da eticisti (nel nostro caso personale il riferimento è ai lavori di Warren T. Reich), secondo cui le teorie etiche hanno per base e alimento una visione di vita buona, una storia dell’origine (credibile ma indimostrabile) in cui si disegna il posto e il ruolo dell’uomo nel mondo. Se questa intersezione di teologia e filosofia è possibile, la fede cristiana sarà messa a confronto con altri tipi di Glaube, senza mettere in epochè il mito in senso forte (si ricorderà la dura polemica tra Jaspers e Bultmann sulla demitologizzazione).
Dicendo questo non ci scostiamo molto dall’approccio di Beauchamp: ogni racconto storico viene riferito al racconto fondatore attraverso un modulo narrativo (UE XVI) già attivo nel primo Testamento, il quale propizia la sinergia tra il movimento vero la fine e il retro-movimento verso l’inizio, in modo da saldare i molti libri in un testo “totale”, che ha il suo punto d’incrocio nella vicenda individuale del Nazareno. Insomma la Bibbia sarebbe un grande testo-mondo, il cui referente sta fuori dal testo, sporgendone, e consiste nella vita, nella storia di salvezza, della quale Gesù è il personaggio definitivo (una delle traduzioni di èschaton). Gesù Cristo prova che la verità delle Scritture è avanti ad esse e non dietro/prima di esse. Ed è una verità che per essere compresa va eseguita come una partitura (espressioni di Beauchamp) dall’ “archi-lettore” (lettore o esecutore individuale e collettivo, presente e continuo). Fede in Dio, fede nella verità trascendente e fede nel libro si toccherebbero asintoticamente.
Dio odia il male, ma lo permette
Su molti altri spunti presenti nel sistematico lavoro di Bertuletti abbiamo dovuto prescindere per ragioni di spazio: il rapporto tra legge e narrazione; la tentazione edenica di voler tutto sapere, senza credere, prima di volere (un tema su cui Giuseppe Angelini ha scritto pagine memorabili); l’impossibilità (secondo Beauchamp, questa volta poco convincente) che Dio combatta contro l’ineluttabile e implacabile forza del destino (UE 273); l’evangelo di Paolo (UE 473 ss.).
Nell’attesa del terzo volume (inshallah!), qualche cosa va almeno detta del primo, in riferimento al secondo. In Dio, il mistero dell’Unico (DM) si trovano le tesi di basi dell’autore: “l’uomo non è capace della verità se non nell’atto – insieme assolutamente necessario e irriducibilmente singolare – che riconosce nell’istanza trascendente che lo rivendica l’origine della propria insostituibile unicità. Questo atto è ciò che la tradizione biblica chiama ‘fede’” (DM 6). Alta sintesi, stile involuto quello di Bertuletti (a volte troppo involuto), concentrazione teorica, esito cogente: occorre “…riconoscere nell’evento di Dio che si rivela ciò che fonda tutto, a cominciare da ciò che lo precede…” (DM 7).
Ricordiamo la vivace polemica che contrappose Bertuletti al metafisico Carmelo Vigna diversi anni fa. Fu un confronto istruttivo, almeno per noi, e non ancora ricomposto, come si evince dalle nostre sovraesposte perplessità in merito all’autonomia filosofica che sarebbe ad un tempo “altra” dalla teologia e tuttavia “costitutiva” di quest’ultima (DM 7).
Bertuletti ribadisce con buoni argomenti la tesi che l’intelligenza della fede non si aggiunga a una fede ingenua, ma sia costitutiva dell’atto autentico di credere (DM 8), e che pertanto l’interrogazione filosofica sia interna a tale intelligenza. Riformulando in termini nostri, il superamento della falsa opposizione tra ratio e fides potrebbe essere la seguente: Dio si rivela non a qualcuno che sia privo di pensieri (Beauchamp in DM 12), ma a un soggetto già conoscente, già carico di interrogativi sul senso del tutto, già incoativamente filosofo, il quale riconosce nel Dio, che a lui si comunica, il principio e il fondamento di ciò che egli andava pensando e credendo.
Reciprocamente il credente, che pensi criticamente la propria fede, auspica l’obiezione di un interlocutore “razionale” poiché l’universalità, rivendicata dalla fede (e incarnata nell’evento unico del Cristo), non potrebbe mostrarsi se non rispondendo alle perplessità di chi dichiara di non credere (di non voler credere o di non poter credere). La filosofia è quindi competente riguardo alla cosa stessa della teologia e la teologia pensa che l’autorivelazione divina sia “condizionata” dall’apertura umana al divino.
Nel solco di questa congettura, Bertuletti documenta filosofo per filosofo (Aristotele, Tommaso, Scoto, Kant, Husserl, Heidegger, Ricoeur, Marion…) le aporie legate al fraintendimento dell’intellectus fidei.
Dio e il bisogno
Ci permettiamo solo due domande. La prima a proposito di un Dio che ha bisogno.
Dio ha bisogno degli uomini? “Dio ha bisogno di Gesù per realizzare la sua verità come verità dell’uomo…Dio si rivela conferendo alla sua creatura la capacità di determinare Dio stesso…l’unico eletto ha bisogno di noi e noi gli diamo ciò che egli è” (DM 353, 446, 450 – parafrasando), scrive Bertuletti e aggiunge, citando Beauchamp a p. 362, che Dio va a tentoni e fruisce della parola dell’uomo che gli fa compagnia e che addirittura partecipa con le labbra alla propria creazione (DM 360). Proprio “grazie-a” (e non “nonostante”) la nostra differenza da Dio, partecipiamo (in forza dello Spirito) della stessa qualità di Dio (DM 451).
Del resto già Hegel diceva che l’assoluto non è senza di noi. Heidegger affermava che l’essere (“Sein”) ha bisogno dell’uomo in quanto “da” del suo manifestarsi (“Dasein”). L’essere si espone consegnandosi all’uomo, commentava Nancy (DM 16, 196 e 200). Ebbene, che bisogno è quello del Dio cristiano? Un desiderio che lascia il desiderante così com’è, sia che il bisogno venga soddisfatto sia che venga frustrato? Oppure il desiderato introduce una vibrazione nell’Amante, lo fa essere “nuovo”, gli mostra cose imprevedibili (come imprevedibile è la libertà dell’uomo vivente)?
Se il Verbo entra nella storia, introducendo la storia in Dio (Ireneo), ciò non può essere senza “effetto” su Dio. La tradizione luterana ha sviluppato la tesi che il Dio, che muore per noi, non viene a sé senza di noi. E se Dio viene a noi in un mondo ancora usurato dal male, egli non è già arrivato, egli cresce tuttora nel grembo e nel patto di/con chi egli stesso ha voluto, posto e scelto come partner.
Divenire, cioè custodire possibilità/potenzialità che passano all’atto, non è una diminutio (scriveva Jüngel) rispetto al rotondo, statico essere parmenideo, che è già tutto in atto (poiché non può non essere e non può neppure venire, poiché passare da qui a là implica un movimento verso altro, un arrivare dove non si era ancora collocati, dunque include un passaggio dal non essere all’essere). C’è una storia comune, “un ‘divenire’ di Dio con Israele” (DM 355).
Dunque, che cosa non cambia di Dio e che cosa invece cambia, facendosi uomo? Se Gesù appartiene alla verità eterna di Dio (DM 571) e se Gesù è divenuto, anche Dio veramente diviene, il che non vuol dire (hegelianamente) che un fondamento processuale indeterminato e impersonale (Grund o Abgrund o Ungrund) preceda il Dio trinitario, ma che quest’ultimo (come in ogni divenire) resta sé mutando e ricevendo dal divenire storico (di Gesù, del credente). L’economia divina rivela l’unicità della sua immanenza: Dio è l’Unico perchè la sua forma dinamica è il movimento d’amore trinitario che si apre all’alterità creaturale (un’ipseità diversa da quella divina) e stringe con essa un’alleanza, in cui il divenire del partner umano introduce novità nell’origine che può essere, con Gesù, chiamata “padre”
Una risposta più chiara alla domanda sul werdende Gott aiuterebbe a comprendere la seguente affermazione: l’assoluto (cioè la libertà originaria propria tanto del Dio della creazione quanto del Dio della speranza – lo stesso Dio alle due estremità dell’economia del dono) si espone alla storia nell’evento cristologico, per presentare all’uomo la figura del compimento senza sostituirsi al suo svolgimento (DM 257, 260). Ora (commentiamo) lo svolgersi della storia della salvezza è come sfogliare un libro che resta eguale a sé? oppure quei fogli di carta diventano un libro solo nella misura in cui il lettore (lo sfogliante) ci mette “dentro” del suo?
L’evento cristologico introduce o no una novità per Dio (come per Schoonenberg e Moingt – DM 508 e 531 – secondo i quali il Verbo e lo Spirito si personalizzano in Gesù)? L’economia del dono lascia l’immanenza divina immutata o la induce a compiere il suo rapporto con l’uomo (il che è a suo modo un divenire)? Tale rapporto (l’intenzione di stare con l’uomo e per l’uomo) non denota forse l’identità di Dio? E non è forse nuovo anche per Dio (DM 536) l’evento di Gesù, evento che non è pura ripetizione tautologica della verità divina? E se Dio, grazie alla finitezza della libertà umana, realizza in modo nuovo ciò che egli (Dio) eternamente è, come pensare metaforicamente tale “realizzazione” (DM 544)? Come connotare e narrare la presenza dell’uomo in Dio e la differenza che il primo “fa” nel e per il secondo?
L’origine, scrive Bertuletti, è estatica (cioè “fuor di sé”, rapportata ad altro) per sua natura, quindi non si può parlare di deduzione o derivazione delle ipostasi (le quali sono la forma in cui il Dio cristiano è unico) e tuttavia l’alterità creaturale è esterna a Dio (mentre le ipostasi sono interne). Come è dunque possibile che Dio si rapporti all’uomo secondo la stessa qualità secondo cui Dio si rapporta al suo Verbo unico (DM 550)? L’autore risponde: è possibile poiché l’alterità creaturale “costituisce una perfezione” che riguarda Dio stesso (ivi).
Lasciamo al lettore giudicare se la costellazione di termini quali «perfezione/determinazione/realizzazione» esprima in modo soddisfacente il farsi “unico” del Verbo infinito assumendo la diversità del finito. Il Verbo sarebbe già unico (poiché riceve dal Padre la destinazione alla Gestalt umana), ma «approfondirebbe» tale unicità facendosi carne. Come possa l’infinitamente altro da Dio «perfezionare» Dio stesso e come possa dirsi che non c’è o non si coglie l’umanità di Dio (nel senso barthiano della Menschlichkeit Gottes), se non perché c’è Gesù (in quanto l’umanità di Gesù sarebbe l’umanità di Dio), tutto ciò risulterà a qualcuno oscuro o tautologico.
Finito e infinito
Seconda domanda. Finito e infinito non sono realtà separate. Dio si rivela conferendo all’uomo la capacità di determinare a) la stessa auto-comunicazione divina e b) la verità dell’irripetibile creatura che Dio ama e salva. Dio si rimette all’uomo, si lascia mettere alla prova dalla vita del credente, che è una vita coscienziale originariamente pratica, in quanto inaugurata dalla decisione di dar fiducia all’altro uomo e all’Altro, unico e in sé invisibile, che rivendica il diritto di promettere e di garantire il compimento della speranza suscitata. Bertuletti non commette l’errore d’identificare (come purtroppo fanno alcuni teologi morali) la finitezza/dipendenza/limitatezza (positiva) con la mortalità (negativa, scandalo teorico e morale). Così, nel commentare Yves Labbè (DM 313 ss.) sul tema della sofferenza ingiusta, si parla della nostra attesa che Dio (prima facie incomprensibile nella sua latitanza) si confermi quale solido alleato ingaggiando vittoriosamente una lotta, con noi e per noi, contro il negativo. La nostra è una spes quaerens intellectum e senza questa speranza non potremmo neppur intelligĕre.
Tuttavia – e questa è la seconda domanda – non si capisce perché questa speranza intelligente dovrebbe precludersi, a priori, l’indagine su “che cosa si deve pensare di Dio di fronte alla sofferenza” (DM 329). Senza una qualche indagine previa, come può l’autore affermare con certezza che il male abbia una funzione anti-speculativa e che l’esperienza del male sia inseparabile dall’esperienza di colpa (DM, 559)? Su Dio si apprende qualcosa di unico, nuovo e imprevisto proprio nella tremenda esperienza “pregata” dal salmo 22! Forse sarebbe più prudente riconoscere che per ora lo scavo teorico non abbia prodotto risultati soddisfacenti. Qualcuno invece ne ha prodotto: il ripudio della ipotesi penalistica e retributiva. Qualche altra scoperta auspicabilmente sarà fatta.
Intanto contestiamo la tesi di Bertuletti che “grazie al patire/morire” di Gesù si compia l’atto escatologico di Dio. Si dovrebbe dire, secondo noi: “nonostante e attraverso”. La tortura mortale cui Gesù fu sottoposto non “causò” in sè niente di buono, né in cielo né in terra. Dio non ha bisogno del male per auto-comunicarsi a noi, nel senso che l’evidenza del male gli permetterebbe di rivelarsi come il Bene assoluto (DM 561). Non ne ha bisogno perché originaria è per noi l’intuizione di un bne infinito e incondizionato, nella cui cornice cogliamo le contraddizioni, le chiazze di negativo del pensiero e della prassi.
La teologia contemporanea è giustamente delusa dalla struttura intellettualistica della teodicea, ma non si può gettare con l’acqua sporca anche il bambino. Non è vero che la teodicea deduca il senso del male da Dio (DM 332). Dal Dio di Gesù deduciamo che il male è un assurdo e che andrebbe tolto e che siamo autorizzati a pregare: “liberaci dal male” rivolgendoci a un padre che tarda a liberarcene. Forse Dio non vuole? Impossibile per l’evangelo! Forse, ipotizziamo, Dio non può e questo “non potere” andrebbe riflettuto meglio. Forse Dio non vuole potere, ossia non vuole esercitare il potere nel modo in cui intendiamo comunemente il termine.
Qualche risposta innovativa verrà, secondo noi, dalle teologhe Usa che si occupano di disability e di disabled God. La teologia della disabilità è infatti abituata a pensare la coppia sofferenza-misericordia in Gesù come una manifestazione unica dell’“umanità” di Dio. Gesù è Dio stesso che patisce, che si fa disabile, che muore, che conserva (da risorto) le sue piaghe e Dio può tutto questo perché nella sua stessa “essenza relazionale (trinitaria) è da sempre inscritta la possibilità di essere determinato dall’uomo” (DM 565).
La teologia della disabilità è abituata a pensare a un Verbo che riceve (riceve anche dolore, riceve anche aiuto) mentre dà. Ne consegue che la croce vale come il segno indelebile di un Dio, che ci viene incontro, avendo memoria di ciò ha patito nell’unicità del Figlio incarnato (DM 565). Non è l’eccesso dell’amore di Dio – il quale sarebbe al di là di ogni ragione – la ragione ultima del male! L’incomprensibilità di Dio non dà, per definizione, alcuna ragione del male, né aiuta l’uomo a farsene una ragione. Caso mai ne raddoppia la negatività: c’è il male, e in più c’è il male/dolore di non capire colui che dà di sé tutt’altra comprensibile e buona notizia e cioè che Dio ci salva e libera.
- A. Bertuletti, L’uomo, evento dell’eccesso di Dio. L’invenzione del soggetto e le sue radici bibliche, Milano, Glossa, 2025, pp. 521, euro 39; Id., Dio, il Mistero dell’Unico, Brescia, Queriniana, 2014, pp. 606, euro 42




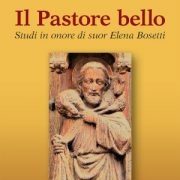

tre pensieri
Se ad uno studente di teologia cade in. mano il Tanquerey o il Di Napoli o altro testo apologetico, lo amerà così tanto da titenere ferragli la teologia che studia Lapologetica attuale non serve a nessuno. Chi la legge non ne trova nutrimento e chi la dovrebbe leggere , altri studiosi o filosofi semplicemente non la leggono
50 anni fa il mio professore diceva. Non capisco i protestanti: dicolo “Sola Scriptura” e nei loro testi teologici si parla sempre di filosofi. per lo più miscredenti (Kant su tutti) Lo stesso vale per Beaucamp, molto interessante a sopravvalutato dopo la semiotica e la filosofia analitica
Ai miei tempi i compagni rifiutarono la Teodicea dicendo che la Scrittura parla da sola. Dopo 60 anni la Teodicea continua a tacere la Scrittura
“Qualche risposta innovativa verrà, secondo noi, dalle teologhe Usa che si occupano di disability e di disabled God.” avendo un fratello disabile, ed essendo praticamente cresciuta in un centro per bambini fortemenete disabili, ammetto che gran parte delle mie domande è rimasto ferma proprio a questa domanda: Perché? Perchè la sofferenza, perchè ad esempio io no e lui si, e via via..
Nello stesso tempo non mi piace molto l’idea che i disabili divengano il prossimo paradigma alla moda, come è stato per gli operai, i poveri, le donne, i LGBT..
Ho iniziato a leggere un testo sulla depressione abbastanza promettente, ma essendo scritto da una teologa americana (che pure ammette di esserci passata) ha il difetto di dover inserire per forza le solite categorie alla moda: i transessuali, il femminismo, le minoranze. E’ tanto complicato pensare che esiste una sofferenza esistenziale che caratterizza l’umano in quanto tale? Una forma di nostalgia di assoluto, un lutto per la propria mortalità innanzitutto, Lacan parlerebbe di rifiuto dell’Edipo in quanto limite.. Si diventa adulti, banalmente sani, quando si accetta di non poter essere o avere tutto.
https://www.queriniana.it/libro/il-deserto-nell-anima-5604